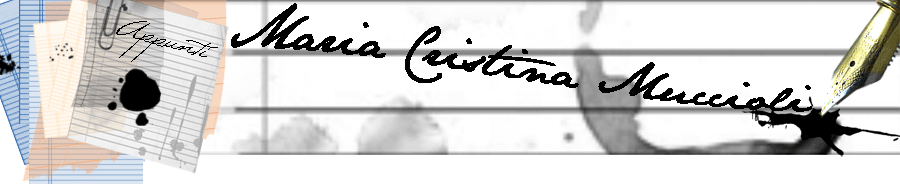Ieri, in esclusiva per pochi amici, per le vie di Rimini sì è svolto un “Amarcord tour”, cioè una giornata dedicata alla scoperta dei luoghi felliniani. Quelli veri legati alla biografia di Federico e quelli ricostruiti a Cinecittà o altrove e immortalati nei vari film del Maestro.
Non era Maria Cristina a fare da guida a Giordano, Raffaella, Glenda e Tony, bensì Cristella, la Regina, quella della bacchetta magica. Infatti è proprio attraverso il blog di Cristella che Giordano, da Reggio Emilia, appassionato dei film di Fellini, ha scoperto un “itinerario felliniano” scritto tempo fa per Menabò Editore e, volendo fare un regalo speciale a Tony, il genero statunitense in Italia per le feste natalizie, ha pensato di portarlo a conoscere la Rimini di Federico chiedendo a Cristella di fare da guida.
Una serie di circostanze favorevoli (non ultima la bellissima giornata festiva col clima ideale) ha permesso la perfetta riuscita dell’esperienza: per Cristella e il Re Consorte una domenica fuori dagli schemi e sicuramente da ricordare. Per Giordano e Raffaella, per Glenda e Tony, la scoperta di una Rimini diversa da quella che conoscono i turisti “normali”. Di certo un’esclusiva.
Proprio in questi giorni il neo-presidente della Fondazione Fellini, Pier Luigi Celli, ha raccontato i progetti per il futuro. La mappa dei luoghi felliniani è quasi pronta, per fortuna, e la ristrutturazione del Cinema Fulgor sta andando avanti. Gli ospiti di ieri hanno molto apprezzato tutto questo, interessandosi molto al cartellone posto sulle impalcature del Fulgor: “Casa Fellini, Museo Fellini, Cineteca e ulteriore sala cinematografica”… Magari coi film che scorrono in continuazione, con le musiche di sottofondo, le foto, i disegni, i costumi di scena… Sì, torneranno di certo, perché quello di ieri è stato solo un assaggio.
Come s’è svolta la giornata?
Il tour è iniziato verso le 11.30. Per motivi legati agli orari dell’hotel dove gli ospiti erano alloggiati e alla presenza di un bimbo di due anni (Giulio, figlio di Glenda) abbiamo stravolto un po’ l’itinerario, iniziando dalla Palata. La passeggiata sulla cima del porto, raccontata da Fellini ne I Vitelloni, è il rito di cui il riminese doc non può fare a meno. Ma si è parlato anche dei pensionati con la canna da pesca, dei pescherecci che ritornano al pomeriggio e vendono sardoni e cannocchie sulla banchina… Uno sguardo alla spiaggia invernale, verso Gabicce, ha evocato l’ultima scena de La dolce vita, con l’innocenza di Valeria Ciangottini e il saluto di Marcello…
Lì vicino, quasi di fronte al Delfinario, anche ieri c’erano i due camioncini dei lupini e delle ‘luvarie’. “Un posto di Rimini che non cambia mai” diceva il Maestro, che ogni volta che tornava comprava qualcosa.
Dopo pranzo siamo saliti in macchina per iniziare il tour vero e proprio. Passando su via Roma, diretti al Cimitero, abbiamo dato uno sguardo alla casa di Amarcord, quella dove abitava Titta Benzi, oggi coperta dalle impalcature per una ristrutturazione. Al Cimitero abbiamo volutamente parcheggiato al di qua del sottopassaggio pedonale. Sul percorso verso il piazzale e l’ingresso, abbiamo letto il ricordo che Fellini aveva di questa entrata che, ai suoi tempi, era interrotta dal passaggio a livello e dal passaggio dei treni. Poi, la vista emozionante della Prua, il monumento di Arnaldo Pomodoro, con la panchina accanto. “Ho pensato alla panchina – ha detto Pomodoro – perché Fellini aveva confidato ad un amico che avrebbe voluto essere sepolto in un parco con una panchina”. Devo dire che i miei ospiti erano già emozionatissimi a questa prima tappa. Leggendo i nomi della lapide si sono stupiti di trovare, sotto a quelli di Federico e di Giulietta, il piccolo Pierfederico, nato nel 1945 e morto piccolissimo, all’età di 15 giorni, di cui non conoscevano l’esistenza.

Risaliti in auto, siamo arrivati al Borgo San Giuliano. Da qui il percorso è proseguito a piedi.
La strada delle Mille Miglia, i murales, le targhe con i soprannomi, i vicoli, i colori delle case dei borghigiani… Ci siamo immersi in un’atmosfera davvero magica.
Un omaggio, poi, al Ponte di Tiberio, ancora in servizio dopo duemila anni, per imboccare il Corso d’Augusto verso il Cinema Fulgor. I lavori in corso con l’indicazione di come sarà nel futuro la “Casa Fellini” sono stati molto apprezzati. Tappa successiva: piazza Cavour. “Lì c’era il bar Commercio, quella è la fontana su cui scende il pavone, là la scalinata del Teatro, dove il 4 novembre 1993 Sergio Zavoli tenne l’orazione funebre…”
Da piazza Cavour abbiamo imboccato via Gambalunga e dato un’occhiata al palazzo che ospitava il Liceo. Poi piazza Ferrari e la “statua dei nudi”, via Tempio Malatestiano fino al piazzale del Duomo.
Prima di una veloce visita al Tempio (bisognerà tornare solo per questo!) un’occhiata al negozio di scarpe lì di fronte (era la bottega della ditta Febo, i disegnatori Demos Bonini e Federico Fellini).
La tappa successiva è stata in piazza Giulio Cesare (oggi Tre Martiri) e al Tempietto di Sant’Antonio, di fronte al quale ci siamo fermati qualche minuto per leggere il racconto delle “baffone”… Quasi per incanto, invece che la “gattaccia di San Leo” ci è parso di vedere la Saraghina di “8 e 1/2”. Per tornare verso piazza Cavour siamo passati davanti al Palazzo Ripa (una delle case in cui Fellini ha abitato) e al luogo dove c’era il Bar di Raoul…
La folla della “vasca” della domenica sul corso ieri era davvero tanta. Un “passeggino” descritto anche da Fellini, che aveva come confini le due piazze…
Risalendo in auto, ci siamo portati alla nostra ultima tappa, forse la più affascinante: il Grand Hotel. Sarà stato per l’orario ideale, le luci degli addobbi natalizi, il giardino, la terrazza e i saloni in quel momento deserti… Insomma, per qualche minuto ci siamo immersi in un’atmosfera di sogno, immaginandoci di veder sbucare da un momento all’altro le figure conosciute di Federico e Giulietta.

Ripeto: esperienza molto bella e forse irripetibile. Da riminese, ringrazio Giordano di avermi “stimolato” a viverla insieme a lui e alla sua famiglia internazionale.
Ringrazio infinitamente la direzione del Grand Hotel e l’amico Vanni Dolcini per la disponibilità riservatami
Infine, se siete arrivati fin qui (ed è già un buon segno!) forse siete interessati anche a leggere qualcosa qui sotto: l’itinerario “La Rimini di Fellini” scritto per Menabò Editor (al quale ho aggiunto qualche piccola nota); alcuni brani tratti da “La mia Rimini” di Federico Fellini (Cappelli, Bologna, 1967) e da “Fare un film” (Einaudi, Torino, 1980); il mio racconto (già presente in questo blog) “Il marinaretto di Fellini).
Av salùt!
LA RIMINI DI FELLINI
(da “52 domeniche in Romagna”, Menabò Editore Forlì)
Il figlio più grande della città è senza dubbio Federico Fellini: il suo cinema è edificato per la maggior parte su memorie dell’infanzia e della giovinezza riminesi. Una Rimini sempre costruita “altrove”, vuoi sul Lido di Ostia o negli studi di Cinecittà, ma con la quale il Maestro ha mantenuto grandi legami affettivi, tant’è vero che ha chiesto di riposarvi per sempre.
E proprio all’ingresso del cimitero si trova il monumento funebre che Arnaldo Pomodoro ha ideato per il regista e per Giulietta Masina: una grande prua rivolta al cielo, che evoca il leggendario Rex di Amarcord.
“Il ‘monumento’ in omaggio a Fellini, come punto di riferimento a Rimini per tutti coloro che l’hanno amato e ancora avranno ammirazione e amore per lui, io l’ho pensato così: con il ricordo visivo della grande metafora o immagine da lui dedicata alla nave (sia in E la nave va, sia in Amarcord). La prua della nave sembra tagliare un percorso ideale attraverso la terra, l’acqua, l’aria: rappresenta per me la grandezza e la gloria stessa dell’opera di Fellini, che aldilà della vota, continua a percorrere il tempo, la storia, l’esperienza sensibile umana”.
L’itinerario nella Rimini felliniana parte proprio da qui, per proseguire verso luoghi, forse già incontrati, da guardare stavolta con occhi diversi, come flash back su scene da Oscar.
Prima tappa al Borgo San Giuliano coi suoi murales dedicati al Maestro e ai suoi film, e al vicino Ponte di Tiberio, dove passava la corsa delle Mille Miglia di Amarcord.
Si imbocca Corso d’Augusto: sulla destra, dopo un centinaio di metri, ecco il cinema Fulgor, l’occhio sul mondo e l’incontro col cinema americano.
Due passi e siamo in Piazza Cavour, con la scalinata dell’Arengo, teatro della celebrazione fascista e della solitaria protesta del grammofono che suona l’Internazionale, e con la Fontana della Pigna, che ha visto le pallate di neve a Gradisca, le scorribande di Scurèza, l’incanto del pavone.
All’angolo con corso d’Augusto c’era il Caffè Commercio (oggi qui ha sede una banca), immortalato in Amarcord.
In questa piazza, affollatissima, il 4 novembre 1993 Sergio Zavoli tenne l’orazione funebre per l’amico di sempre, prima di accompagnarlo verso il cimitero cittadino. Quel giorno Rimini si fermò. Per l’ultimo saluto al Maestro arrivarono migliaia di persone: la testa del corteo era già al Cimitero e la coda ancora in piazza.
Da piazza Cavour si svolta in via Gambalunga dove, nel Palazzo Gambalunga, oggi Biblioteca e Cineteca, aveva sede il vecchio Ginnasio teatro di mille goliardate. Dalla finestra si poteva vedere Piazza Ferrari e il suo monumento ai caduti della Grande Guerra (i “nudi delle statue”).
Proseguendo verso la stazione ferroviaria (il treno, metafora di ogni partenza, molto cara al Maestro) si passa in via Oberdan, dove, nella casa della sorella Maddalena, ha sede (aveva sede, ora il Museo è in via Nigra; nota dic. 2010) il Museo Fellini.
In via Roma sorge ancora la casa dell’amico Titta (l’avvocato Luigi Benzi, tuttora vivente), il ragazzo protagonista di Amarcord, palco della mitica scena del litigio familiare a tavola, con la tovaglia che vola insieme a tutte le stoviglie
Lì vicino, al numero 91 di via Clementini, la casa dell’adolescenza di Federico e del primo amore per Bianchina: il Palazzo Dolci.
Si prosegue verso il Duomo: lì di fronte la bottega di Demos Bonini, dove Fellini iniziò a disegnare. Più avanti, piazza Tre Martiri (ex piazza Giulio Cesare), con la chiesa dei Paolotti (“le baffone”, pag. 6). Per tornare verso piazza Cavour passiamo di fronte all’ex bar di Raoul, rifugio dei “vitelloni” (ex magazzini Oviesse).
Le ultime tappe ci portano verso il mare: il molo (la “palata”, meta invernale dei Vitelloni e teatro delle bravate di Scurèza, il motociclista di Amarcord) e il bar Zanarini, loro meta estiva .
Terminiamo in piazzale Fellini, al’ombra del mitico Grand Hotel, simbolo di tutti i desideri “proibiti”, luogo felliniano per antonomasia.
Qui, nella suite n. 316, il 3 agosto 1993 Federico Fellini fu colpito dall’ictus.
“La mia Rimini” di Federico Fellini
Brani tratti da La mia Rimini, Cappelli, Bologna, 1967 e Fare un film, Einaudi, Torino, 1980
Il mio amico Bagarone, il mio compagno di scuola, la mia Rimini…
Stanotte ho sognato il porto di Rimini che si apriva sopra un mare gonfio, verde, minaccioso come una prateria mobile sulla quale correvano nuvoloni carichi, verso terra.
Io, a Rimini, non torno volentieri. Debbo dirlo. È una sorta di blocco. La mia famiglia vi abita ancora, mia madre, mia sorella: ho paura di certi sentimenti? Soprattutto mi pare, il ritorno, un compiaciuto, masochistico rimasticamento della memoria: un’operazione teatrale, letteraria. Certo, essa può avere il suo fascino. Un fascino sonnolento, torbido. Ma ecco: non riesco a considerare Rimini come un fatto oggettivo.
È piuttosto, e soltanto, una dimensione della memoria. Infatti, quando mi trovo a Rimini, vengo sempre aggredito da fantasmi già archiviati, sistemati.
Forse questi innocenti fantasmi mi porrebbero, se vi restassi, un’imbarazzante muta domanda, alla quale non potrei rispondere con capriole, bugie; mentre bisognerebbe tirar fuori dal proprio paese l’elemento originario, ma senza inganni. Rimini: cos’è. È una dimensione della memoria (una memoria, tra l’altro, inventata adulterata, manomessa) su cui ho speculato tanto che è nato in me una sorta di imbarazzo…
…Eppure debbo continuare a parlarne. A volte, anzi, mi chiedo: alla fine, quando sarai più ammaccato, stanco, fuori competizione, non ti piacerebbe comprare una casetta sul porto? Il porto della parte vecchia. Da bambino lo vedevo di là dall’acqua: vedevo costruire scheletri di barche. L’altro braccio, stando di qua, lasciava immaginare una vita da baruffe chioggiotte, che non aveva nulla a che fare coi tedeschi che andavano sul mare con la Daimler Benz.
La casa a Rimini. Quelle che ho abitato le ricordo bene, tranne una: la casa natale, in via Fumagalli.
Quando avevo già sette anni, una domenica pomeriggio, facevamo la passeggiata in carrozza. D’inverno il landò era chiuso. Ci stavamo dentro in sei: i miei, i fratelli, la donna di servizio, ammonticchiati al buio, perché il finestrino doveva stare chiuso, altrimenti entrava la pioggia. Io non vedevo niente. Soltanto, nell’oscurità, le facce di mio padre e di mia madre. Una gran gioia era, quindi, quella di sedere accanto al vetturino perché là in alto si respirava.
Quella domenica pomeriggio la carrozza svoltò in un viale mai fatto: una serie di case tutte unite una all’altra. Papà disse: ‘Sei nato lì’, e la carrozza filò via. La prima casa che io ricordo veramente è il palazzo Ripa. C’è ancora: è un palazzo sul Corso (Corso d’Augusto 115). Il nostro padrone di casa andava sempre vestito di blu: l’abito blu, la bombetta blu e una gran barba bianca, come una divinità da blandire, da non irritare. Mia madre si asciugava le mani, mentre diceva: ‘Bambini, state fermi, c’è il signor Ripa’. Poi entrava il vecchione…
…Pensare a Rimini. Rimini: una parola fatta di aste, di soldatini in fila.
Non riesco a oggettivare. Rimini è un pastrocchio, confuso, pauroso, tenero, con questo grande respiro, questo vuoto aperto del mare. Lì la nostalgia si fa più limpida, specie il mare d’inverno, le creste bianche, il gran vento, come l’ho visto la prima volta.
Un’altra casa nostra, cioè abitata da noi, era vicina alla stazione. La casa dove m’è parso di avere il segno della predestinazione. Era una villetta col giardino davanti. Il grande orto che stava dietro comunicava con un enorme edificio – una caserma, una chiesa? – sul quale stava scritto, in lettere bianche a semicerchio: ‘Poli… ama riminese’.
Mancavano due lettere, cadute, perdute. Siccome l’orto di casa nostra era infossato, il terreno che reggeva l’edificio, dietro il muretto di cinta, appariva più alto, là in cima.
Una mattina, stavo nell’orto a costruire un arco con una canna, quando si sentì improvvisamente un frastuono. Era il rotolio enorme della saracinesca del teatro, che non avevo mai notato e che si stava sollevando. Alla fine apparve un’immensa apertura nera. Nel mezzo, stavano un uomo con un baschetto e un imper-meabile e una donna che faceva la calza. Seguì un dialogo. L’uomo: ‘L’assassino deve essere entrato dalla finestra’. La donna: ‘La finestra è chiusa’. L’uomo: ‘Il sergente Johnatan ha trovato tracce di scasso’. Poi l’uomo s’era rivolto a me che stavo nell’orto: ‘Ci sono i fichi in quell’albero?’ ‘Mah, non lo so’.
Stavano provando il Grand Guignol: la compagnia di Bella Starace Sainati. Questa casa vicino alla stazione è la stessa delle prime amicizie. La casa di via Clementini 9, invece, è quella del primo amore…
…Il padrone di casa, ‘Agostino Dolci e F. ferramenta’, era il padre di Luigino, un mio compagno di scuola del ginnasio, quello che nell’Iliade faceva Ettore (recitavamo per conto nostro l’Iliade).
Nel palazzo di fronte abitava una famiglia meridionale, i Soriani, con tre ragazze. Elsa, Bianchina e Nella. Bianchina era una moretta: dalla mia camera da letto la potevo vedere. La prima volta mi apparve dietro il vetro della finestra, oppure – non ricordo – vestita da piccola italiana, coi bei seni pesanti, già da madre.
Per me le donne, allora, erano soprattutto le zie. Avevo sentito parlare, è vero, di una casa con certe donne dentro.
La Dora in via Clodia, dalle parti del fiume. ‘La Dora de fiom’. Ma, quando dicevano ‘le donne’, mi venivano in mente solo le zie che facevano i materassi, le donne di Gambettola, dalla nonna, che passavano il grano al setaccio. Quindi non capivo. Poi ho visto che le zie erano diverse perché la Dora affittava due carrozze e, ogni quindicina, faceva vedere la nuova covata giù per il Corso, a scopo di propaganda. Allora ho visto passare donne dipinte, con velette strane, misteriose, che fumavano sigarette col bocchino d’oro: le donne nuove della Dora.
Ritroviamo “la Quindicina” della Dora nei racconti di Zavoli.
(da “Romanza” di Sergio Zavoli, 1987, Mondadori Editore).
“Le falene, così erano chiamate dagli studenti, arrivavano in città un sabato sì e uno no, come reparti che si diano il cambio sulla linea del fronte. Una catena che non oso chiamare di Sant’Antonio, teneva legate l’una all’altra le ‘case’, un provvido scambio quindicinale serviva a rinnovare la scena, se non proprio il copione. La domenica, a mezzogiorno, era di rito la passeggiata con la carrozza scoperta perché la gente vedesse. L’esibizione attirava un codazzo di bambini che si arrampicavano schiamazzando sul mantice, respinti da mani quasi materne. I virtuali clienti occhieggiavano dalle finestre, dai bar, dai negozi, valutando pezzo per pezzo quel bouquet di donne offerto all’invisibile platea in un modo che accordasse la propaganda con la discrezione, le regole della salvaguardia privata con quelle della pubblica sicurezza. Così, mentre dalle vetture le ragazze si guardavano intorno, attraverso vetrine e finestre la gente perbene vedeva e non vedeva. Alla fine della passerella – girato l’angolo e presa la strada della stazione, con la città finalmente alle spalle – i cavalli volgevano quasi in fuga verso il mare, sospinti dalle grida festose delle falene. E lo spettacolo, quello innocente, finiva lì.”
L’asilo l’ho frequentato presso le monache di San Vincenzo, quelle col cappellone. Un giorno, mettendomi in fila per una processione, mi diedero da portare una candelina…
…Una di queste monache, con gli occhiali, pareva Harold Lloyd, mi disse in maniera perentoria, indicando la candela: ‘Non la fare spegnere, perché Gesù non vuole’. Soffiava un gran vento. Bambino, fui sopraffatto da quella grande responsabilità. C’era il vento e la candela non si doveva spegnere. Che cosa mi avrebbe fatto Gesù? La processione, intanto, s’era mossa, tarda, pesante, a lenti passi a fisarmonica. Una corsetta, un arresto, ancora avanti, poi di nuovo fermi. Che cosa facevano in testa alla colonna? In processione si doveva anche cantare. ‘Noi vogliam Dio, ch’è nostro padre…’ In mezzo a quello stuolo di sottane, di frati, di preti, di monache, all’improvviso scoppiava un fragore mesto, di note spente, solenni.
Era la banda, che mi spaventava. Alla fine mi misi a piangere.
Alle scuole Teatini feci la prima e la seconda elementare. Io stavo in classe con quel Carlini insieme al quale avevo visto l’impiccato sul Marecchia. Il maestro era uno scazzottatore di alunni che diventava improvvisamente buono in occasione delle feste, quando i genitori gli portavano i regali, che ammonticchia-va presso la cattedra, una gran pila come fanno i vigili per l’Epifania. Ricevuti quei grandi regali, prima di liberarci per le vacanze ci faceva cantare: ‘Giovinezza giovinezza, primavera di belleeeezza’: a quelle quattro ‘e’ teneva moltissimo.
Gli anni dopo le elementari, fui mandato a farli a Fano, presso il piccolo collegio provinciale dei padri Carissimi. È di quel tempo l’incontro favoloso con la Saraghina così come l’ho raccontato in 8 e ½.
Tornai a Rimini, al ginnasio, che era in via del tempio Malatestiano, dove ora sono la Biblioteca comunale e la Pinacoteca…
…Quello del ginnasio mi sembrava un palazzone altissimo. La salita e la discesa delle scale era sempre un’avventura. C’erano scale che non finivano mai. Il preside, detto Zeus, una specie di Mangiafuoco, aveva un piede grosso come una 600, col quale tentava di ammazzare i bambini. Dava calci da schiantare le schiene. Fingeva l’immobilità; poi, di colpo, arrivava una zampata che ti schiacciava come una scarafaggio.
Quelli del ginnasio sono gli anni di Omero e della ‘pugna’. A scuola si leggeva l’Iliade, mandandola a memoria. Ciascuno di noi si era identificato con un personaggio di Omero. Io ero Ulisse, stavo un poco in disparte e guardavo lontano.
Titta, già corpulento, era Aiace Oileo, Mario Montanari Enea, Luigino Dolci ‘il domatore di cavalli Ettore’ e Stacchiotti, il più anziano di tutti perché aveva ripetuto ogni classe tre volte, era ‘il piè veloce Achille’.
Il pomeriggio si andava in una piazzetta a ripetere tra noi la guerra di Troia, lo scontro fra i troiani e gli achei. Andavamo, appunto, a ‘fare la pugna’. Portavamo i libri legati alla cinghia, come si usava, e, brandendo i libri, ce li scaricavamo addosso, mescolando colpi di libri e cinghiate.
La sera si andava al mare, scomparendo in banchi di nebbia, nella Rimini invernale: le saracinesche abbassate, le pensioni chiuse, un gran silenzio e il rumore del mare.
D’estate, invece, per tormentare le coppie che facevano l’amore dietro le barche, ci si spogliava in fretta, quindi ci si presentava nudi, chiedendo all’uomo dietro la barca: ‘Scusi, che ora è?’…
…Di giorno, siccome ero magro e avevo il complesso d’esser magro, – mi chiamavano Gandhi o canocchia – non mi mettevo in costume.
Vivevo una vita appartata, solitaria; cercavo modelli illustri, Leopardi, per giustificare quel timore del costume, quell’incapacità di godermela come gli altri, che andavano a guazzare nell’acqua (per questo, forse, il mare è così affascinante per me, come una cosa mai conquistata: la zona dalla quale provengono i mostri e i fantasmi).
In ogni caso, per riempire quel vuoto, mi ero dato all’arte. Avevo aperto con Demos Bonini una bottega artistica; sulla vetrina c’era scritto ‘Febo’ (ndr: oggi, 2011, c’è un negozio di scarpe).
Si facevano caricature e ritrattini alle signore anche a domicilio. Io firmavo Fellas, chissà perché, e facevo il disegno: Bonini che era un vero pittore ci metteva i colori.
La bottega della ditta Febo stava proprio davanti al Duomo che d’estate diventava ancora più bianco, un osso di seppia, e la notte faceva luce come la luna. Quella calcarea apparizione così estranea e solenne che non assomigliava a nessuna altra chiesa, a nessuna altra costruzione, mi aveva sempre affascinato con un sentimento di mistero e di soggezione.
La chiesetta dei Paolotti, invece, aveva un piccolo tempio a forma di battistero, staccato dalla costruzione principale, dove, ogni tanto, le ‘baffone’ portavano gli animali per farli benedire dai frati. Si chiamavano ‘baffone’ per la peluria dorata o bruna che visibilmente ricopriva il labbro e il polpaccione sodo, guizzante. Noi, fuori, contavamo febbrilmente le biciclette accatastate contro il muro della chiesa per sapere quante ‘baffone’ erano venute giù…
…Da un fanalino rotto, da un pedale senza gommino, da certi aggeggi fabbricati in casa e applicati con spranghe e spaghi ai manubri, sapevamo se dentro la cappella c’era anche la ‘baffona’ di Santarcangelo, coi capelli rossi, che portava il maglione ‘argentina’, senza reggipetto sotto; e le due sorelle di Santa Giustina, quadrate e spavalde, che si allenavano per partecipare al giro d’Italia. La bicicletta che solo a vederla ci faceva battere il cuore svelto svelto, era quella della gattaccia di San Leo, una gladiatrice torva e possente, con un gran nuvolone di capelli neri, gli occhi fosforescenti come i leoni, ti guardava lenta, indifferente, senza vederti.
Sbirciavamo ansiosi dentro il tempietto risonante di belati, starnazzamenti, ragliacci. Finalmente le ‘baffone’ uscivano coi polli, le capre, i conigli, e montavano in bicicletta. Era questo il grande momento! I musi appuntiti delle selle infilandosi rapidi come sorci tra le sottane scivolose di satin nero lucente, scolpivano, gonfiavano, facevano scoppiare, in uno scintillio di riflessi abbaglianti, i più bei culoni di tutta la Romagna.
In quel tempo, per partecipare alla cricca dei vissuti, si stava con gli amici al bar di Raoul, il ‘caffè degli amici’, a metà del Corso. Raoul era grassottello, con una faccetta rotonda, molto attivo. Il bar, fatto sull’esempio dei milanesi d’allora, era frequentato dagli artisti, dalla gioventù inquieta, dagli sportivi. Vi si faceva un po’ di fronda politica, un timido accenno. Era il luogo di ritrovo dei vitelloni, d’inverno (d’estate, tutto si spostava al mare, da Zanarini. Importante: a Rimini esiste una divisione netta tra le stagioni. È un cambiamento sostanziale, non solo meteorologico, come in altre città. Son due Rimini diverse)…
…La Rocca, la prigione di Francesca, era, allora, piena di ladruncoli di sacchi di cemento e di ubriachi. Quel tozzo e tetro edificio m’è sempre rimasto in testa come una presenza nera, nel ricordo della mia città.
Davanti alla Rocca c’era un piazzale polveroso, sul quale sostavano i circhi: un piazzalone sbilenco, dove finiva la città. Il clown Pierino si esibiva col suo circo, scambiando invettive coi carcerati che, attraverso le sbarre delle finestre, gridavano cose tremende alle cavallerizze.
Il Grand Hotel, al contrario, era la favola della ricchezza, del lusso, dello sfarzo orientale.
Quando le descrizione nei romanzi che leggevo non erano abbastanza stimolanti da suscitare, nella mia immaginazione, scenari suggestivi, tiravo fuori il Grand Hotel, come certi scalcinati tea-trini che adoperano lo stesso fondale per tutte le situazioni. De-litti, rapimenti, notti di folle amore, ricatti, suicidi, il giardino dei supplizi, la dea Kalì: tutto avveniva al Grand Hotel.
Le sere d’estate il Grand Hotel diventava Istanbul, Bagdad, Hollywood. Sulle terrazze, protette da cortine di fittissime piante, forse si svolgevano feste alla Ziegfield. Si intravvedevano nude schiene di donne che ci sembravano d’oro, allacciate da braccia maschili in smoking bianco, un venticello profumato ci portava a tratti musichette sincopate, languide da svenire. Erano i motivi dei film americani: Sonny boy, I love you, Alone, che l’inverno prima avevamo sentito al cinema Fulgor e che poi avevamo mugolato per interi pomeriggi, con l’Anabasi di Senofonte sul tavolino e gli occhi perduti nel vuoto, la gola stretta.
Soltanto d’inverno, con l’umidità, il buio, la nebbia, riuscivamo a prendere possesso delle vaste terrazze del Grand Hotel fradice d’acqua…
…Ma era come arrivare a un accampamento quando tutti sono andati via da un pezzo e il fuoco è spento.
Si sentiva nel buio l’urlo del mare: il vento ci soffiava in faccia il pulviscolo gelato delle onde. Il Grand Hotel, chiuso come una piramide, le sue cupole e i pinnacoli inghiottiti dalla nebbia, era per noi ancora più estraneo, proibito, irraggiungibile.
La vita andava via lenta, anche al caffè Commercio, che stava all’angolo di piazza Cavour, un caffè per bene, frequentato dalla borghesia, dai professionisti, il parquet di legno, il cioccolato alle cinque del pomeriggio, il biliardo, gli scacchi. Il caffè dei vecchi, che intimidiva un po’.
Al caffè Commercio c’era Giudizio, un ritardato, che aiutava le donne a scaricare il furgone, che lavorava come un somaro, perché era un somaro. Alle sei di sera, Giudizio abbandonava di colpo quei lavori fatti per niente e se ne andava a passeggiare sul lungomare, vestito come un clown. In mezzo agli stranieri, infatti, veniva colto da una sorta di rapimento mondano. D’inverno, invece, rimetteva in piedi i birilli del biliardo per qualche sigaretta. Conosceva tutte le carambole. Di notte, faceva un ulteriore servizio di vigilanza notturna. Si cacciava in testa un berretto trovato da qualche parte e andava in giro a mettere, sotto le saracinesche dei negozi, dopo il cartellino ‘Visitato’ della vera vigilanza, un altro cartellino con su scritto: ‘Anche io’.
Siccome, per via della Bottega dell’Arte, io ero diventato un personaggetto abbastanza noto, avevo fatto un contratto col proprietario del cinema Fulgor. Costui assomigliava a Ronald Colman e lo sapeva…
…Portava l’impermeabile anche d’estate, i baffetti, e manteneva una costante immobilità, per non perdere la somiglianza, come fanno quelli che sanno di assomigliare a qualcuno. I lavori che facevo per lui – caricature di ‘divi’, interpreti dei film in programmazione, messe nelle vetrine dei negozi a scopo di propaganda – gli erano dati in cambio dell’ingresso gratuito al cinema Fulgor.
Allora, noi si stava sempre in città. Poche volte si usciva nei dintorni. Ricordo la Collina delle Grazie, un santuario con la via crucis, cui si può far risalire il quaresimale terrificante, miracolistico, apocalittico della religione, da me ritrovato in seguito, in certe sequenze.
Su per la collina c’erano tante cappellette a zig-zag. Una volta, per una cerimonia di Quaresima, s’era accampata sulla collina una gran festa: contadini, vecchie, fetore, lupini, cartate di salame, uno che vomitava. Salivano in ginocchio, cantando, per raggiungere l’ultima stazione. In testa a tutti don Giovanni urlava: ‘… e cadde per la seconda volta’.
Poi, avvenimenti ancor più drammatici, in un crescendo fosco, mortuario, sanguinante. Chi lo sa perché era sempre così? Perché tutto quello che aveva a che fare con la religione doveva sempre spaventare?
In quel periodo, alla religione si aggiunsero le facce dei fascisti. Qualcuno di costoro credo che avesse picchiato mio padre. Io sospettavo certi ceffi che stavano al bar in camicia nera. Mio padre mi teneva nascosta la cosa. Quando cadeva il discorso su certi argomenti, egli scambiava occhiate complici con mia madre, per non farmene partecipe…
…La mia confusione aumentò il giorno in cui vidi quei ceffi sospetti cantare in chiesa, insieme all’arciprete.
Alle adunate io non portavo mai la divisa completa: mi mancavano, volta a volta, le scarpe nere, i pantaloni grigio-verdi, il fez. Era un tiepido sabotaggio per non apparire interamente fascista: da irregolare, istintivamente insofferente di quel clima militaresco, e mortuario come le processioni.
Un giorno, Starace doveva passare per Rimini. Alla stazione spuntò un treno imbandierato. C’era un gran sole. La banda esplose, squillarono le trombe, il treno entrava in stazione soffiando un gran fumo bianco, restò Starace, un ometto, con un gran nasone, che disse:
‘Camerati riminesi…’ La gente impazzì, forse perché l’ometto aveva detto: ‘riminesi’; squillarono di nuovo le trombe: credo che Starace non abbia detto altro. Il re, invece, lo andammo a vedere a Forlì, allineati sui marciapiedi della stazione.
Un luogo affascinante, di Rimini, era il cimitero. Mai visto un posto meno lugubre. Intanto stava di là da un passaggio a livello, perciò era preceduto dalla visione emozionante, allegra, del treno. Le sbarre si abbassavano suonando: si vedeva, di là, un muretto chiaro, con tanti cunicoli, come casette di bambini. L’ho scoperto quando morì il nonno. Noi nipoti fummo caricati sopra una carrozza. Il vetturino, per farci tacere, infilava la frusta in un foro della berlina chiusa, cercando di colpirci…
…Fu una grande scampagnata. Cominciammo a correre fra le tombe, a nasconderci. Ricordo il fascino di tutte quelle facce: le foto sulle tombe. Che la gente vestisse, prima di allora, in un altro modo, l’ho sco-perto al cimitero. Vedevo altrettanti nomi, tutti conosciuti: Baravelli, Benzi, Renzi, Fellini, le famiglie riminesi. Il cimitero era sempre in costruzione, quindi c’era aria di festa. I muratori, lavorando, cantavano. Una stupenda contadina, che teneva la baracca dei fiori, la mattina passava in bicicletta. Preparava i mazzi di fiori con lo spago, che spezzava con i suoi denti robusti. Bionda, se ne stava in un vestito slacciato di satin nero, a piedi scalzi, bagnata.
Se ne parlava ancora, di questa contadina, durante il ‘passeggino’ lungo il Corso: tutte le sere, mezzo chilometro compiuto a passo di lumaca. Dalla pasticceria Dovesi fino al Caffè Commercio. Come si accendevano le luci, cominciava il ‘passeggino’, fatto di ammiccamenti, brevi risate. Erano due correnti in senso inverso, che si rincorrevano. A furia di camminare, pareva che la gente consumasse sempre più la parte inferiore del corpo.
Oltre piazza Cavour, uno dei capolinea, laggiù in fondo c’era il buio della campagna. Dall’altra parte, oltre piazza Giulio Cesare, un altro buio. Così il ‘passeggino’ avveniva, caldo, trepido, appassionato, tra quelle due zone di buio.
La stazione era, invece, il luogo dei sogni avventurosi. I treni. Il campanellino del treno. I binari che si biforcavano in mezzo alle siepi. Appena lo scampanellio cessava, si vedeva il treno all’incrocio dei binari, silenzioso: il rumore veniva dopo. Una volta vedemmo un treno tutto blu. Era il vagone letto. Si alzò una tendina, apparve una signora in pigiama…
…Sono partito da Rimini nel ’37. Ci sono tornato nel ’46. Sono arrivato in un mare di mozziconi di case. Non c’era più niente. Veniva fuori dalle macerie soltanto il dialetto, la cadenza di sempre, un richiamo: ‘Duilio, Severino!’ quei nomi strani, curiosi.
Molte delle case che avevo abitato non c’erano più. La gente parlava del fronte, delle grotte di San Marino in cui si erano rifugiati e io provavo la sensazione un po’ vergognosa di essere stato fuori dal disastro.
Mi colpì l’operosità della gente, annidata nelle baracche di legno: e che parlassero già di pensioni da costruire, di alberghi, alberghi, alberghi: questa voglia di tirar su le case.
A piazza Giulio Cesare i nazisti avevano impiccato tre riminesi. Adesso c’erano dei fiori per terra. Ricordo che ebbi una reazione infantile. Quello spettacolo mi pareva un oltraggio sproporzionato. Ma come, non c’è più il Politeama, non c’è più quell’albero, la casa, il quartiere, il caffè, la scuola! Mi pareva che avesse dovuto frenarli il rispetto per certe cose. Sta bene, è la guerra: ma perché distruggere proprio tutto?
Forse Rimini io l’avevo già cancellata per mio conto, in precedenza. La guerra aveva compiuto anche l’atto materiale. Allora mi pareva, poiché la situazione s’era fatta irreversibile, che tutto, invece, dovesse restare.
Intanto, però, Rimini, io l’avevo ritrovata a Roma. Rimini, a Roma, è Ostia.
Prima di quella sera, Ostia non l’avevo mai cercata. Ne avevo sentito parlare come della ‘spiaggia decisa dal duce’, ‘Roma adesso ha il suo mare’, ciò che me la rendeva antipatica. Tra l’altro, stando a Roma, non sapevo nemmeno da che parte fosse il mare…
…Una sera, c’era già l’oscuramento, gli autobus passavano silenziosi, schermati di luce azzurra; la penombra rendeva ancor più la città quel paesone che è, remota e solitaria. Noi stavamo festeggiando qualcosa in una pizzeria, coi colleghi, con Ruggero Maccari. Avevamo bevuto; pareva che il ristorante dovesse rovesciarsi. Nel mezzo di quell’allegria ubriaca Ruggero dice: ‘Venite con me. Prendiamo un tranvetto’.
Sceso dal tram, dopo il viaggio notturno, sentii all’improvviso l’aria più fresca. Eravamo a Ostia. I viali deserti, gli alberoni che si muovevano a causa del vento: ho visto, di là da una balaustra di cemento, come a Rimini, che c’era il mare.
Un mare nero: che mi fece venire la nostalgia di Rimini; e che era anche una scoperta gioiosa, segreta, come pensare: vicino a Roma c’è un posto che è Rimini.
A Ostia ho girato I vitelloni perché è una Rimini inventata: è più Rimini della vera Rimini. Il luogo ripropone Rimini in maniera teatrale, scenografica e, pertanto, innocua. È il mio paese, quasi pulito, nettato dagli umori viscerali, senza aggressioni e sorprese. Insomma è una ricostruzione scenografica del paese della memoria, nella quel puoi penetrare, come dire?, da turista, senza restare invischiato.”
Nota 1
Ritroviamo “la Quindicina” della Dora nei racconti di Zavoli.
(da “Romanza” di Sergio Zavoli, 1987, Mondadori Editore).
“Le falene, così erano chiamate dagli studenti, arrivavano in città un sabato sì e uno no, come reparti che si diano il cambio sulla linea del fronte. Una catena che non oso chiamare di Sant’Antonio, teneva legate l’una all’altra le ‘case’, un provvido scambio quindicinale serviva a rinnovare la scena, se non proprio il copione. La domenica, a mezzogiorno, era di rito la passeggiata con la carrozza scoperta perché la gente vedesse. L’esibizione attirava un codazzo di bambini che si arrampicavano schiamazzando sul mantice, respinti da mani quasi materne. I virtuali clienti occhieggiavano dalle finestre, dai bar, dai negozi, valutando pezzo per pezzo quel bouquet di donne offerto all’invisibile platea in un modo che accordasse la propaganda con la discrezione, le regole della salvaguardia privata con quelle della pubblica sicurezza. Così, mentre dalle vetture le ragazze si guardavano intorno, attraverso vetrine e finestre la gente perbene vedeva e non vedeva. Alla fine della passerella – girato l’angolo e presa la strada della stazione, con la città finalmente alle spalle – i cavalli volgevano quasi in fuga verso il mare, sospinti dalle grida festose delle falene. E lo spettacolo, quello innocente, finiva lì.”
Il marinaretto di Fellini
(racconto di Maria Cristina Muccioli)
Esterno notte.
Sera d‘estate a Rimini. Terrazza del Grand Hotel. La facciata dell’albergo è illuminata a giorno. Musica di sottofondo affidata alla magica voce di una bella ragazza mora seduta al pianoforte. Numerosi ospiti in abito da sera ai grandi tavoli rotondi. Via-vai di camerieri in giacca bianca.
E’ il 13 luglio 2008.
Paolo ed io siamo fra gli invitati al Gran Galà dello Ior, l’Istituto Oncologico Romagnolo, di cui siamo volontari da diversi anni.
Non siamo ospiti di primaria importanza, ma gregari. Forse per questo il tavolo riservato a noi e ai nostri amici è ai bordi della terrazza, l’ultimo della fila.
Per fortuna, penso ora.
Da quella postazione non ho mancato di ammirare gli ospiti veri del Grand Hotel: i clienti residenti che stavano cenando nella sala da pranzo le cui vetrate erano lì, a portata dei miei sguardi curiosi.
Non vi dico l’eleganza di signore e signori! Molti evidentemente erano stranieri. Li osservavo quando, di tanto in tanto, si alzavano per recarsi al bar o per uscire ad ascoltare il nostro concerto.
La mia attenzione, a un certo punto, è stata attirata da un bimbetto sui sette anni che aveva in mano un video-gioco (o forse era una pallina verde?). Biondo, capelli lisci e lunghi fino alle spalle, calzava un enorme berretto da marinaio e vestiva alla marinara.
Mi dispiace solo di non aver avuto la prontezza di fotografarlo. Quindi, pur non essendo brava a disegnare, ho provato a fissarlo su carta con penna e pastelli.
Eccolo.
I genitori, giovani e biondi pure loro, magri e belli, potevano essere inglesi o russi. Comunque stranieri.
La visione di questo bambino mi ha colpito perché avevo appena letto, sulle pagine di un quotidiano locale, un articolo di Gianfranco Angelucci, ai tempi stretto collaboratore di Federico Fellini, che racconta la cronaca del 3 agosto 1993, quando il Maestro venne colpito da un ictus mentre si trovava qui, al Grand Hotel.
“Quel giorno – raccontava il regista – fui salvato da un angelo vestito da marinaretto”.
La figura del marinaretto ritorna spesso nella vita, reale e onirica, di Fellini.
“Qualche volta mi capitano sotto gli occhi delle fotografie dove ci sono anch’io, col vestito da marinaretto, ritto in piedi con mio fratello, dietro a mio padre e mia madre seduti su due poltroncine di velluto; lo ricordo perché abbiamo dovuto portarle da casa fino allo studio del fotografo, socialista e sorvegliato dal Questore”.
E in quasi tutti i suoi film il marinaretto appare, anche solo fugacemente.
Un sogno divenuto ossessione, forse. O il contrario…
In quel caldo martedì d’agosto di quindici anni fa, dicevamo, quando l’ictus colpì il regista alloggiato nel suo Grand Hotel, si disse che l’allarme venne dato da un piccolo ospite straniero vestito da marinaretto. Il bambino, sentendo i lamenti provenienti dalla stanza 316, aprì la porta, trovò il maestro riverso sul pavimento e corse a chiamare aiuto.
Ma in quei giorni nessun bambino con quelle caratteristiche alloggiava al Grand Hotel.
Realtà o sogno? Solo Federico potrebbe dirlo.
Nei giorni scorsi, a Bellaria, ho avuto l’occasione di incontrare Sergio Zavoli, il grande giornalista amico di sempre di Fellini. Gli ho chiesto se avesse mai sentito parlare di questa versione dei fatti. Un sorriso malinconico ha accompagnato la sua risposta.
“No, cara. Non è andata proprio così. Ma stai certa che Angelucci l’ha saputo dal diretto interessato: una delle tante ‘storie vere’ raccontate dal fantasioso Federico.”
Oltre a disegnare, in questi giorni mi sono divertita a scrivere un raccontino su questa strana coincidenza.
La pallina verde del marinaretto
Nel corridoio del terzo piano la moquette rossa attutiva il rumore dei passi dei clienti e del personale.
La penombra dell’ambiente, in quell’afoso pomeriggio d’agosto, suggeriva un’idea di fresco, che però non corrispondeva del tutto alla sensazione reale.
Era l’ora della pennichella.
Limpio, il facchino addetto al piano, lavorava al Grand Hotel da quasi quindici anni. Non solo valigie da portare su e giù, ma anche lavori di piccola manutenzione, che in un albergo come questo non mancavano mai. Un rubinetto che sgocciola? Un interruttore bloccato? Una lampadina da sostituire?
“Me la cavo un po’ con tutto – stava spiegando Limpio all’Eleonora, la cameriera brunetta intenta a sistemare il materiale della guardiola riservata al personale del piano – I miei capelli grigi la dicono lunga: da giovane ho fatto il muratore, l’imbianchino, l’idraulico, il fabbro, l’autista, il cuoco… Chiamami pure, quando trovi qualcosa che non funziona. C’è un problema? Arriva Limpio, che tutto sistema!”
Soddisfatto della rima e dell’espressione di rispetto apparsa sul volto della donna, il facchino decise di riposare un po’. Tra l’altro, sedendosi al tavolino poteva sbirciare meglio le forme esuberanti della collega, a malapena contenute nella divisa bianca e rosa.
L’uomo buttò l’occhio all’orologio da polso.
“Sono solo le tre e un quarto – sbuffò tra sé e sé – Sa ste chèld, us starébb mej a marèina (con questo caldo, si starebbe meglio in riva al mare).”
E, piegando la testa sul tavolino, quasi senza accorgersene, si appisolò…
“Ma dai, non dirmi che ti disturbo, che non ti credo! Non sono mica le tre di notte!”
Il Maestro era in canottiera. Con la schiena appoggiata a due cuscini parlava al telefono, steso sul letto della stanza 316. Il salottino e la camera della suite erano in penombra. Dalle porte-finestra che si affacciavano sul grande parco giungevano pochi rumori: a Rimini anche le automobili e i motorini a quell’ora vanno a riposare.
Le persiane accostate lasciavano filtrare un sottile raggio di sole che, come una stilettata, andava a toccare la mano destra del maestro. L’indice piegato seguiva le curve dei ghirigori del copriletto damascato, quasi a volerli ridisegnare con un gessetto invisibile.
Sul tavolino accanto al letto, in fila come tanti soldatini, i flaconi e le scatole delle medicine: l’anticoagulante, la compressa per la pressione, l’antibiotico…
“Sì, sì, che sto bene, Gianna, sta’ tranquilla – continuava il Maestro – Lo sai che qui sono come a casa, no? Dormo, leggo, telefono, vedo gli amici. Giulietta è tornata a Roma questa mattina, sarà quasi arrivata, ormai. A pranzo sono stato da Maddalena. Questa sera, invece, viene a prendermi il Grosso: andiamo all’Osteria del Borgo, vicino al Ponte di Tiberio. Fanno dei galletti in umido da leccarsi le dita! Ora provo a dormire un po’: stanotte l’ho fatta quasi tutta in bianco, non riuscivo a prender sonno. La fatica più grande è star dietro a tutte queste medicine! Una la mattina, l’altra prima di pranzo, un’altra ancora alle quattro spaccate… Insomma, un s’capéss pròpri gnint, non si capisce proprio niente! Pensa che per organizzare questa specie di farmacia che mi ritrovo in camera, ieri ho dovuto chiedere a Limpio di spatacare con legno e chiodi per modificare il tavolino. Adesso ho tutto qui, a portata di mano. Va bene, Gianna, ci sentiamo domani. Mi telefoni tu? Ciao, bella.”
Il Maestro piegò il busto e allungò il braccio per riattaccare la cornetta del telefono.
Ma, che strano, non si ricordava che il tavolino fosse così lontano dal letto. Qualcuno l’aveva spostato? Un’ombra nera gli passò davanti agli occhi. Poi, improvvisamente, un lampo.
“Che succede? Cos’è questo silenzio improvviso?”
Ad un tratto, una sensazione mai provata prima.
Su e giù… Come sbattuto da un uragano improvviso… Di qua, di là… La testa gira, gira… La mano si apre, la cornetta cade a terra, sbatte sulla moquette senza far rumore…
“Oddio, sto male. Cosa mi succede? Devo chiamare qualcuno! Il telefono… Gianna, Gianna, hai già chiuso? Aiuto, aiutatemi. Help, help me!”
Tum- tum-tutum…
“Ma cos’è questo rumore soffocato nel corridoio? Sembra una palla che rimbalza… Qualcuno che viene a salvarmi?”
Tum-tum-tutum…
Uno spiraglio di luce inonda la stanza.
La porta si apre quel tanto per far entrare un bambino sui sette anni vestito da marinaretto. Il cappello blu con la visiera, troppo grande per lui, gli copre le orecchie e lo rende molto buffo. Biondi e lisci come quelli di una bambola, i capelli gli arrivano alle spalle. Indossa una maglietta a righe e larghi pantaloni bianchi che arrivano al polpaccio.
Nelle mani tiene una pallina verde. Quella del tum-tum-tutum.
Il bambino guarda il vecchio caduto dal letto, senza capire le sue parole.
“Aiut… Chiama qualc…”
Poi, finalmente, una parola conosciuta.
“Help me!”
Il marinaretto biondo corre nel corridoio.
E’ ormai grande, lui! Ha capito che quel signore sta male e ha bisogno di aiuto.
Si ricorda di aver visto il facchino e la cameriera, sullo stesso piano, e di esser sgattaiolato via per paura che lo rimproverassero. Mamy si era raccomandata di non fare rumore con la palla, che quello era un albergo di lusso e bisognava portare rispetto agli altri ospiti. “Be quiet, baby!”
Limpio sentì un venticello che gli spettinò i capelli brizzolati e si svegliò di colpo dal torpore della pennichella. Il silenzio era stato interrotto da un leggero rumore, un tum-tum-tutum mai sentito prima.
“C’è corrente. Che strano. Qualche porta rimasta aperta? Meglio dare un’occhiata.”
L’Eleonora, intanto stava spolverando lo specchio al lato opposto del corridoio.
Limpio si alzò per andare a fare il suo giro di controllo.
E subito si accorse di qualcosa di diverso: la porta della stanza 316 era socchiusa e a terra, proprio lì davanti, c’era una pallina verde non ancora ferma del tutto, come se qualcuno avesse appena finito di farla rimbalzare.
Non sapeva cosa pensare, Limpio, ma decise la sola cosa da fare: correre, correre il più velocemente possibile a vedere cosa succedeva. Guai, se a causa della sua distrazione qualche malintenzionato si fosse introdotto nelle stanze degli ospiti! Tanto più in quella del grande regista Federico Fellini, convalescente da un intervento chirurgico, che da qualche giorno alloggiava lì.
“Eleonora, vieni anche tu! Dev’essere successo qualcosa alla 316!”, chiamò mentre si dirigeva verso la stanza del Maestro.
La mezzora che seguì rimase fissata per sempre nella memoria di Limpio e di Eleonora e nei giorni seguenti riempì le pagine dei giornali di tutto il mondo.
“Fellini, brivido a Rimini nel suo Grand Hotel”, titolava la stampa del 4 agosto 1993.
“Parla ed è cosciente. Da poco era stato operato al cuore in gran segreto a Zurigo. Il maestro, convalescente dopo l’applicazione di un bypass, era solo in camera quando ha perso i sensi. Soccorso da una cameriera e da un facchino. La moglie è tornata subito da Roma. Fellini si è sentito male nella sua camera d’albergo, verso le 15.30. Era solo e un improvviso svenimento l’ha fatto cadere battendo la testa. Una cameriera e un facchino che passavano per il corridoio hanno sentito qualcosa, sono entrati nella stanza e hanno dato l’allarme.”
Fellini morì a Roma il 31 ottobre 1993.
E’ stato sepolto nel cimitero di Rimini, subito dopo l’ingresso, nei pressi della zona monumentale e antica.
In una delle vecchissime tombe dai decori scrostati che circondano l’ultima dimora di Federico, di Giulietta e di Federichino, è sepolto un bimbo dal nome straniero morto “in circostanze drammatiche”, all’età di sette anni, nel lontano 1908, mentre coi genitori era in vacanza a Rimini.
La fotografia è appannata e confusa: un grande berretto blu copre a malapena i suoi lunghi capelli biondi.
Il bimbo della fotografia sorride ammiccante, con lo sguardo rivolto alla scultura dell’artista Arnaldo Pomodoro posta sulla tomba dei Fellini.
Al bambino quella prua di nave ricorda le onde, il vestito da marinaretto, la sua pallina verde.
La stessa che aveva trovato sulla spiaggia il giorno dell’incidente, quando con mamy e daddy era fra i primi ospiti del Grand Hotel appena inaugurato.
Lo ricorda benissimo: erano alloggiati nella stanza 316, al terzo piano.