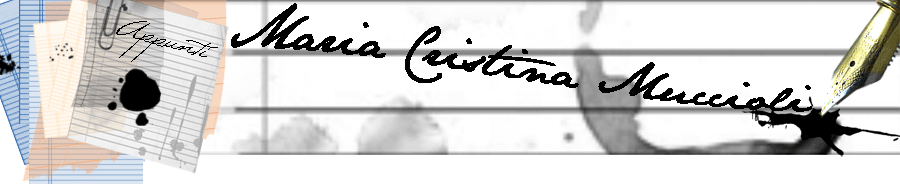Davvero incredibile come Raffaello Baldini, in La nàiva, abbia saputo anticipare lo scenario che la sua Santarcangelo (e tutta la nostra Romagna) sta vivendo in questi giorni. Continuo a pubblicare… Ce n’è ancora un bel pezzo. Per farci coraggio, anticipo uno degli ultimi versi: “...e’ vén sò e’ sòul…” (viene fuori il sole).
Buona lettura… av salùt ma tòtt!
LA NAIVA (3^ parte)
di Raffaello Baldini (da “La nàiva, furistìr, ciacri”. Giulio Einaudi Editore, 2000)
E la matéina dop u i déva ancòura.
Mal finestri de bsdèl
u s’avdéva dal fazi dri di véidar.
Dal butàighi i scapéva a sbadilé,
la zénta sòtta i pòrtich
i batéva sal schèrpi còuntra e’ méur.
La calèva lizìra, cmè una ghèrza,
la parzéva i scaléin de Monumént,
la cuvréva al cadéini tònda l’Erch,
me cantòun ad Medardo,
tachèd la pòrta, u s’era fat un réifal
ch’l’arivéa guèsi fina e’ luminèl.
Se teràz dl’Irma i pan stéis i era téinch,
d’ogni tènt i dindléva tòtt insén.
Una machina te Bòurgh la gnuléva,
la n’ s vléva invié.
In piaza qualch’ burdèl si stivèl ‘d gòmma
e’ travarsèva,
d’ilt te Baròun i zughéva a pisé,
i fèva di béus zal,
e la nàiva l’era cmè ch’ la tarléss.
E la mattina dopo ci dava ancora. Alle finestre dell’ospedale si vedevano delle facce dietro i vetri. Dalle botteghe uscivano a spalare, la gente sotto i portici battevano con le scarpe contro il muro. Calava leggera, come una garza, pareggiava gli scalini del Monumento, copriva le catene attorno all’Arco, alla cantonata di Medardo, vicino alla porta, s’era fatto un refolo che arrivava quasi fino ala lunetta. Sulla terrazza della Irma i panni stesi erano stecchiti, ogni tanto dondolavano tutti assieme. Una macchina nel Borgo mugolava, non si voleva avviare. In piazza qualche ragazzino con gli stivali di gomma attraversava, altri nel Baròun giocavano a pisciare, facevano dei buchi gialli, e la neve era come se tarlasse.
U i à dè tòtt la nòta, la matéina
e’ réifal ad Medardo u n gn’era piò.
Se marchè un chéll ad màili l’è rivàt
ma novzént frènch, du scarciòffal zént schéud,
e i à puléi.
Che struncòun ‘d biciclètta
puzèda vsina e’ ciòcch, senza padròun,
la era ancòura alè, u s’i avdéa la sèla.
Da Lino i tnéva sémpra la luce zàisa,
l’era pin ‘d fòmm, i véidar i culéva.
Un’òura pasmezdè
te Prè un tiglio u s’è sbrènch, cmè una puràza,
mo l’arlòzz de Cuméun e’ féva agli òngg,
u s’i era inciudè al sféri.
Ci ha dato tutta la notte, la mattina il refolo di Medardo non c’erra più. Sul mercato un chilo di mele è arrivato a novecento lire, due carciofi cento scudi, e hanno pulito. Quello sganghero di bicicletta appoggiata vicino al Ciòcch, senza padrone, era ancora lì, le si vedeva la sella. Da Lino tenevano sempre la luce accesa, era pieno di fumo, i vetri colavano. All’una del pomeriggio nel Prato un tiglio s’è sbrancato, come una vongola, ma l’orologio del comune faceva le undici, gli si erano inchiodate le sfere.
E l’era sémpra nàiva,
i méur dal chèsi i s’era fat canéud,
da la pscaréa l’arivéva un rugiadézz,
l’era tòtt passaròtt, i aveva trov
da stè alè dréinta, i gev’ès dal zantnèra,
Ed era sempre neve,
i muri delle case si erano fatti canuti,
dalla pescheria arrivava uno schiamazzo, erano tutti passerotti, avevano trovato Da stare lì dentro, dovevano essere centinaia…
CONTINUA