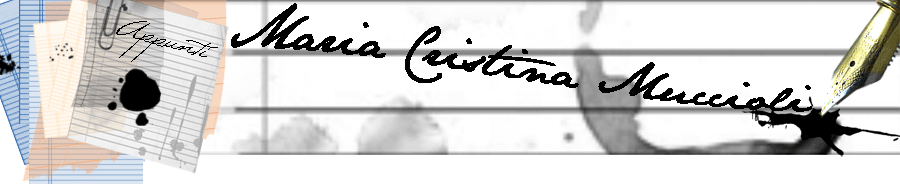Michele Marziani, esperto di cibi non solo romagnoli, nel suo libro “La cucina riminese tra terra e mare” dice di lei: “Tipica dell’area di Rimini e Riccione, è un’ode allo strutto, un inno al palato. Bella, grande, ricca di strutto, è cosa per golosoni e per braccia robuste. Tirarla col matterello non è semplice, ma il risultato è di quelli da grandi occasioni.”
Ma cosa sarà mai questo oggetto del mistero, inno del palato da riservare ai giorni di festa?
Si tratta della piada sfogliata riminese, ormai introvabile se non in qualche casa dove c’è ancora una nonna di buona volontà e di ottima memoria.
Una risorsa così preziosa non manca di certo, nella reggia di Cristella.
Ecco allora giunto il momento di presentare la signora Malvina, la mia suocera riminese doc, nonna sempre attiva e depositaria delle ricette tramandatele negli anni. Le sono state maestre sua nonna Elisa e sua suocera Rosa, arzdore nate verso il 1880-1890.
Quando nonna Malvina decide di regalare la piada sfogliata è festa, in famiglia: non è mica roba di tutti i giorni! Al massimo a Carnevale e forse un’altra volta o due durante l’anno. Perché la preparazione richiede almeno una mezza giornata di lavoro, tanta pazienza e una manualità che ormai s’è perduta.
Dopo lo stretto corteggiamento di nuora e nipote, la nonna ha ceduto e sorride davanti alla videocamera mentre spiega i vari passaggi della ricetta. Fiera di passare i suoi saperi alle due generazioni più giovani della famiglia.
La protagonista di questa sinergia fra donne è quindi lei, l’arzdora Malvina.
Fondamentale, però, anche il ruolo di Dora, la nipote esperta webmaster e studentessa di nuovi media alla Facoltà di Scienze di Tor Vergata. Così come fatto con la prima ricetta (ricordate gli strozzapreti?) che ad oggi è stata visualizzata da quasi 900 persone, Dora partecipa al progetto come regista, filmando il tutto e occupandosi del successivo montaggio e della destinazione finale su Youtube. Nel mezzo, come il prezzemolo, Cristella, nuora di Malvina e mamma di Dora, anello di congiunzione con idea e testi.
Mentre la nonna prepara e spiega, vengono fuori i ricordi di ragazza.
“Sapete? – racconta – Quando mia suocera Rosa negli anni Venti era la cuoca di Villa Ombrosa, la proprietaria, la contessa Gemmamaria, le ordinava le piade sfogliate ogni volta che aveva ospiti con cui voleva fare bella figura.”
Come succede con la preparazione dei cappelletti alla vigilia di Natale, anche con le piade sfogliate la preparazione diventa un rito che unisce buona parte della famiglia. Non si può affrontare l’impresa da sole: bisogna essere almeno in due o tre. Ad ognuna il suo ruolo, magari scambiandolo ogni tanto. Una tira la sfoglia, l’altra l’arrotola e la tira un’altra volta, la terza la cuoce sul testo.
Alla fine, il risultato di questo lavoro d’équipe non può che essere gustoso, a favore di familiari ed amici. Sì, perché oltre che inno alla golosità, come dice Marziani, la piada sfogliata è fatta per la convivialità, per essere mangiata in allegre tavolate riscaldate da buon vino.
Il video, parola di Cristella, stimola le papille gustative. Questo, almeno, è quanto è successo a me in fase di doppiaggio. Sarà perché la visione di tutte quelle piade impilate sul tavolo della cucina mi ha ricordato il profumo di quel giorno d’estate in cui le abbiamo gustate…
Insomma, nel video si vede come si fa e qui di seguito vi scrivo la ricetta. Gli strumenti ora li avete pure voi. Se riuscirete a copiare e cenerete con qualche piada sfogliata vuol dire che siete veramente bravi.
Io, fintanto che ho la Malvina, me la tengo ben stretta. Invidiatemi pure.
Al massimo, potreste provare a farvi invitare direttamente da lei, per la prossima “piadata” di famiglia.
Buon appetito! Ci rivediamo su Youtube alla prossima ricetta romagnola.
Ricetta della piada sfogliata della signora Malvina
Ingredienti per circa 25 piade
1 kg di farina
½ bicchiere di olio extravergine di oliva
1 bicchiere di acqua tiepida
2 cucchiai di sale
1 uovo
strutto di maiale
Preparazione
Impastare farina, uovo, olio, sale, acqua fino ad ottenere un impasto morbido. Farne delle palline della grossezza di un mandarino. Lasciarle riposare, coperte da un panno, per almeno un’ora.
Passato questo tempo tirare le palline col matterello aiutandosi con altro olio. Devono diventare molto sottili. Spalmare ogni piada con lo strutto e arrotolarla su se stessa per ottenerne un rotolo che si chiuderà a forma di chiocciolina. Lasciarla riposare ancora (un’altra ora come minimo), affinché lo strutto, sciogliendosi, “sposi” l’impasto.
Ora è il momento della seconda tirata di matterello.
Anche questa volta ci si aiuta con l’olio, perché la piada deve diventare sottilissima, ancor meglio se con qualche buco.
Una volta pronta, si stacca ogni piada dal tagliere prendendola con le due mani e si posa con delicatezza sul testo (la piastra di ghisa o di terracotta che si usa in Romagna per cuocere la piadina), che deve essere rovente.
Si rigira un paio di volte aiutandosi con un grande coltello a lama piatta.
A differenza della piadina classica, questo tipo di piada durante la cottura non va punzecchiata.
La piada sfogliata è buona anche da sola, ma per una cena da non dimenticare andrebbe accompagnata con formaggi morbidi (tipo stracchino e squacquerone) e con affettati misti.
Obbligatorio, non solo consigliato, un buon vino. Sangiovese, naturalmente.
Buon appetito!