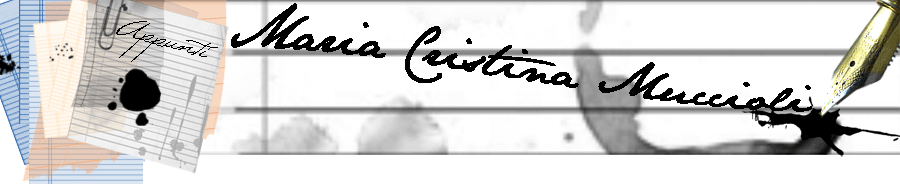Alla farfalla il poeta romagnolo Tonino Guerra ha dedicato una bella poesia ed alcuni disegni che gli artigiani dell’Antica Stamperia Pascucci di Gambettola hanno recentemente utilizzato per tovaglie, cuscini, tende...
La Farfàla
Cuntént própri cuntént
a sò stè una masa ad vólti tla vóita
mó piò di tótt quant ch’i m’a liberè
in Germania
ch’a m sò mèss a guardè una farfàla
sénza la vòia ad magnèla.
La farfalla
Contento proprio contento
sono stato molte volte nella vita
ma più di tutte quando mi hanno liberato
in Germania
che mi sono messo a guardare una farfalla
senza la voglia di mangiarla.
Tonino Guerra è stato prigioniero dei nazisti come mio padre Martino. Ha sempre raccontato, Tonino, che proprio nel periodo di prigionia il dialetto romagnolo, con l’atmosfera che sapeva ricreare, fu un’ancora di salvezza per lui e per i compagni conterranei. I suoi racconti nella ‘lingua madre’ facevano risentire suoni e profumi e tentavano di ricreare, almeno un po’, il calore di casa. Mi piace pensare che forse anche mio padre era fra quei compagni che Tonino ha riscaldato con le sue poesie.
E’ mi bà l’è sté prisunìr in Polonia. E racuntèva sempar che i l’aveva mandé a lavuré da dì cuntadéin. La fiòla de padroun l’ a s ciamèva Marta e la s’era un pò inamurèda de mi bà. “Wenn Krieg ist fertig, ich komme in Italien mit dir, Martino!”. Par furtouna l’a n’è vnouda, la Marta: mé a n saréb mai nèda. A cà u’i era la mi mà, la su bèla murousa, ch’l aspitèva!
Il mio babbo è stato prigioniero in Polonia. Raccontava sempre che lo avevano mandato a lavorare da dei contadini. La figlia del padrone si chiamava Marta e si era un po’ innamorata del mio babbo. “Quando la guerra sarà finita, io vengo in Italia con te, Martino!”. Per fortuna non è venuta, la Marta, io non sarei mai nata. A casa c’era la mia mamma, la sua bella morosa, che lo aspettava!
Per ricordare i circa 700.000 italiani che, come Martino e Tonino, sono stati prigionieri in tempo di guerra, proprio in questi giorni a Rimini si può visitare una mostra fotografica, a cui ho dedicato il seguente articolo.
Resterà aperta fino al 28 ottobre al Palazzo dell’Arengo, in piazza Cavour, la mostra fotografica “Prigionieri per la libertà” organizzata dal sindacato Cisl. Si tratta di un interessante percorso della memoria che ricorda la vicenda degli internati militari italiani durante la seconda guerra mondiale: una ventina di bozzetti in bianco e nero e a colori e oltre cento immagini scattate dal tenente di Marina Vittorio Vialli, geologo appassionato di disegno e fotografia. I luoghi sono quelli condivisi dai circa 700.000 soldati catturati dopo l’armistizio badogliano: i campi di prigionia tedeschi e polacchi. Le date sono incise nella storia: dall’8 settembre 1943 fino alla liberazione avvenuta nella primavera del 1945. Vialli fotografa il momento della partenza da Corinto dopo la cattura; il viaggio sui vagoni da bestiame durato trenta giorni; la vita quotidiana condivisa coi suoi compagni, con fame e violenze gratuite; l’arrivo del primo mezzo corazzato inglese che li liberò; il ritorno in patria nell’estate del ’45. “Ci auguriamo che la mostra diventi itinerante – hanno detto i responsabili della Cisl durante l’inaugurazione – Questi italiani, rifiutandosi di aderire alla RSI e per questo catturati dai tedeschi che li ritennero traditori, hanno rappresentato una ‘prima Resistenza’, come ha recentemente dichiarato il presidente Napolitano. Le fotografie sono a disposizione di scuole, comuni, sindacati e associazioni che volessero richiederle.” Fra il numeroso pubblico presente all’inaugurazione, anche alcuni reduci: ultraottantenni fieri e commossi nell’indicare ai più giovani i luoghi della prigionia ben evidenziati sulla grande carta geografica posta all’ingresso. Per loro, i “lavoratori coatti” o “schiavi di Hitler” che i tedeschi obbligarono a condizioni disumane in miniere, fabbriche e fattorie, pesa ancora la beffa del mancato riconoscimento di qualsiasi indennizzo da parte della Repubblica Federale Tedesca. Su 120.000 domande presentate attraverso i patronati sindacali nel 2001, solo 3.000 sono state accolte (se la prigionia era per motivi razziali o religiosi). “Lei è stato un Internato Militare Italiano, non un detenuto in campo di sterminio”, questo si legge nella “giustificazione” inviata dallo IOM di Ginevra (l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) al signor Martino Muccioli, classe 1917 e scomparso nel 2002. Fu catturato in territorio dell’ex Jugoslavia il 10 settembre 1943 e per quasi due anni sudò in una fattoria polacca, dormendo nelle stalle accanto alle bestie. Altra sorte, invece, per le domande di indennizzo di chi lavorò in territorio austriaco. “A mio padre Elio, ex combattente e catturato in territorio albanese – racconta l’assessore Roberto Biagini – arrivò un assegno di circa 2.500 euro da parte della Fondazione di Riappacificazione Austriaca proprio il giorno prima della morte, il 9 settembre 2005.” Esattamente sessantadue anni dopo quello storico 8 settembre. Magra consolazione, verrebbe da dire. Come quella, del tutto simbolica, della proposta contenuta nella legge finanziaria 2007 per il conferimento di una medaglia d’onore “a tutti i cittadini deportati e internati nel lager nazisti” (art. 1, commi dal 1271 al 1276). Loro, i pochi ex deportati ancora in vita, aspettano ancora. Ai più, la medaglia, se ci sarà, verrà portata sulla tomba.
La mostra è aperta tutti i giorni (escluso lunedì), dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.
[tags] Tonino Guerra, mostra, resistenza[/tags]