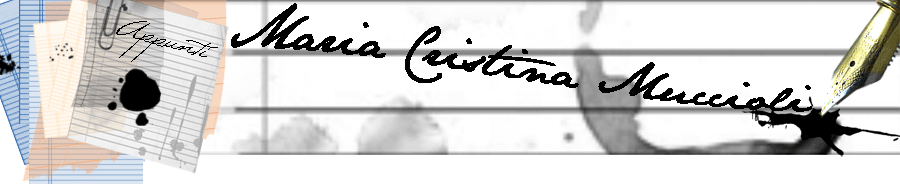Qualche volta, al mattino, faccio fatica ad alzarmi dal letto. Mi sento affannata e ho un senso di peso sul petto… Potrebbe trattarsi di pura pigrizia o stanchezza.
Ma forse, chissà, potrebbe anche essere che… non ditelo a mio marito, però… durante la notte sia venuto a trovarmi “e’ mazapégul”.
E’ mazapégul, dispettoso folletto dal berrettino rosso, l’ho incontrato per la prima volta ai tempi delle mie ricerche per il libro Trama e ordito, mamme che tessono la vita. Era, fra le altre cose, ritenuto responsabile degli sgambetti alle brave tessitrici.
Così, infatti, racconta lo scrittore folclorista di Sarsina Vittorio Tonelli: “Sul batti e ribatti del pettine e dei pedali una giovane tessitrice ritmava canzoni d’amore in faccia alla tela nascente del suo corredo da sposa. Muoveva svelta la spola nella trama di quel tessuto di sogno. Ed ogni volta se la sentiva sfuggire di mano, a volte tra il brusìo dei cannelli agitati. Ma chi era l’invisibile cavalier servente che le raccoglieva via via la drugla da terra, senza parole, nel respiro ovattato di un palpito? Era… un folletto innamorato: lo stesso nanetto dal berretto rosso che di notte le giaceva sul ventre, platonicamente o che faceva i dispetti in casa, mettendo sottosopra le stanze, spegnendo le candele, spettinandola mentre dormiva.”
E’ mazapégul, ch’l a e’ biritoci ròs e la bèrba ad legul (Il mazapégul, che ha il berrettuccio rosso e la barba di legolo), mi raccontava l’amico giornalista televisivo Marco Magalotti, nato a Sorrivoli di Cesena.
Lo spiritello cambiava nome a seconda dei luoghi: mazapégul, caicarèl, zapàider, fulèt, mazapès…
Per Gianni Quondamatteo “e’ mazapégur” (o mazapégul) è lo spiritello, folletto che ama – secondo la superstizione – dormire con donne. E anche, secondo le nostre credenze – spiritello maligno che si divertiva a far dispetti ai contadini e nelle stalle. Infine, con questo nome si definisce il senso di oppressione, di peso al petto che si prova, talvolta, dormendo, dovuto ad ambascia, a soverchio cibo, o altro.”
Fantasia popolare senza confini: il mazapégul romagnolo è presente anche in Puglia (mazzamuriello, munaciedde), a Roma (mazzamurello), ad Ancona e Jesi (mazzamurèllo), in Lucchesia (linchetto), in Campania (munaciello), in Lucania (monachiccio), sul Gargano (scazzanuridd).
A chi volesse avventurarsi in un curioso viaggio fra i folletti italiani, consiglio una visita al blog di Placida Signora, che ne ha scritto approfonditamente in questo post.
Buon divertimento!