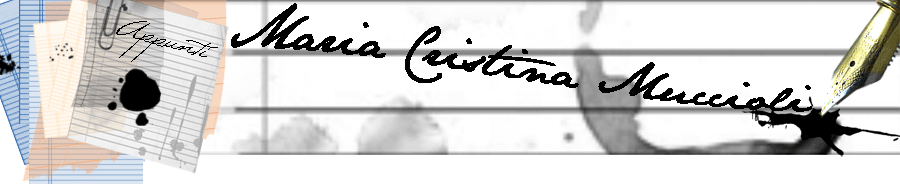Ci sono ancora, eccomi!
Dopo la sfacchinata sui tetti di Rimini di sabato notte e la sudata di domenica al centro commerciale Le Befane sto lentamente tornando nei panni di Cristella, quelli “à la tous les jours”.
Ciò significa che ogni mattina alle sette e mezzo ci si mette in macchina nel traffico di Rimini per andare in ufficio, dove c’è un badge da timbrare in orari mica tanto flessibili, un centinaio di persone che cercano lavoro con cui parlare ogni giorno, altrettante telefonate cui rispondere, nuovi colleghi con cui riorganizzare la micro-struttura che con altri (i “vecchi” colleghi) avevamo messo su negli ultimi 8-9 anni… Che volete che sia… Quisquilie, direbbe Totò.
Perché mica finisce lì: una volta tornate a casa bisogna anche fare la spesa, predisporre la cena, pensare agli addobbi natalizi che rischiano di rimanere in bella mostra per settimane, fare un salto dal medico per una ricetta, ritirare le analisi, portare la Fiesta nuova a fare il tagliando, scrivere un articolo che è stato richiesto da tempo, rispondere senza ansia a chi ti chiama sul cellulare nei momenti meno indicati. Eccetera eccetera eccetera.
Qualcuno sa dirmi perché in questo periodo ho la pressione alta?
Vatti a rileggere la poesia di Raffaello Baldini dove si dice, all’orologio che corre sempre: “férmat, pataca!”
A proposito, avete visto l’ultima pubblicità televisiva con Valentino Rossi e Paolo Cevoli? Uno si affaccia alla finestra per dare del “pataca” all’altro (notare che “si dà del…”, non “si dice…”).
Godetevi questo pezzo di Zelig, visto che ci siamo.
Dopo la parola “amarcord” sdoganata da Tonino Guerra e Federico Fellini (che in realtà sarebbe composta da due parole: “am arcord”, mi ricordo, voce del verbo “arcurdès”) anche “pataca” è forse destinata a diventare d’uso comune nella lingua italiana?
In tal caso, non fate figuracce: ricordatevi (arcurdév) che si scrive con una sola “c”. Mi raccomando!
Am arcmand: “pataca”.
Adesso mi fermo anch’io.
Devo ancora appendere al chiodo la scopa da Befana e chiudere nell’armadio, fino all’anno prossimo, la sottana e le calze rotte.