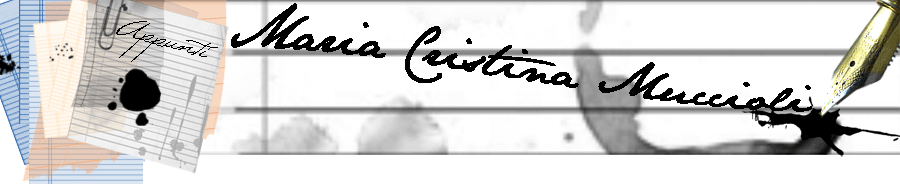Burdéll, la è è gnara! (ragazzi, è dura!).
Questa frase, sepolta nelle pieghe della mia memoria di bambina, ha la voce di mio padre, grande lavoratore, che, nonostante i calli e la fatica, spesso ritornava dal cantiere a tasche vuote.
Uno dei ricordi più dolorosi della mia infanzia è quando il “padrone” rimandava a casa i suoi operai senza dar loro il dovuto.
Al primo giorno del mese, dopo cena, il babbo mi chiamava al tavolo della cucina (ero già la scrittrice della famiglia!). Su di un foglio strappato dal quaderno mi faceva fare il conto delle ore lavorate. Prendeva il calendario appeso al chiodo vicino al lavello e iniziava a dettare: lunedì 1 dicembre: 8 ore, martedì 2 dicembre: 8 ore, mercoledì 3 dicembre: neve (e giù imprecazioni!).
Poi, insieme, facevamo il totale. Il giorno dopo, con questo foglietto, si presentava al suo capomastro per chiedere il salario. Sembrava quasi lo mendicasse!
Erano gli anni Sessanta. Nel paese, per fortuna nostra e di tanti altri, ci si conosceva tutti e il rispetto reciproco era garanzia sicura per piccoli prestiti fra vicini e, da parte della bottegaia, per il librettino dove si segnava la spesa quotidiana.
Si saldava quando si poteva, di solito appena arrivava la busta-paga di quel “padrone” tirchio e furbastro (che con questi mezzucci s’è tirato su un bell’albergo in riva al mare).
Ricordo bene, quando andavo alla bottega per comprare mezzo chilo di zucchero e un litro di latte e invece di pagare facevo segnare sul librettino. Quest’ultimo, in fondo, era l’antenato della moderna carta fedeltà, che uso oggi al supermercato e che mi addebita tutte le spese a fine mese…
Ma torniamo alla frase che ispira questo post: “burdéll, la è gnara!”
L’ho rivolta alla mia giovane collega (che per questioni anagrafiche non conosce né il dialetto, né i tempi del librettino della spesa) qualche giorno fa. A metà mattina, nel pieno dell’attività quotidiana di informazione al bancone del Centro per l’impiego, eravamo già al livello di guardia. Il nostro ufficio è un vero crocevia di bisogni e di richieste a cui, con l’aria che tira, l’istituzione può dare poche risposte.
La è gnara, burdéll!
Dal mio punto di vista (sono “in trincea” da quasi trent’anni) posso tranquillamente affermare, senza timore di venire smentita, che a Rimini tanta gente in cerca di lavoro non s’era mai vista. Di tutte le provenienze (anche per i cercatori di lavoro Rimini è, storicamente, “terra di conquista”), di tutte le tipologie (generici, impiegati, specializzati) e di tutte le età (e questo fa molto male: quando arrivano persone della mia generazione o anche più grandi, troppo giovani per la pensione, troppo vecchie per riciclarsi).
Ma cosa possiamo offrire? Anche a Rimini si parla di aziende che chiudono e di cassa integrazione. Il turismo? Anche ad essere ottimisti, con la crisi globale, non so se tanta gente verrà in vacanza come in passato… I posti di lavoro stagionali – nel settore turistico-alberghiero e nell’indotto – ne risentiranno di sicuro.
Vabbè, speriamo che qualcosa cambi in meglio…
Immaginatevi, comunque, le mie giornate a cercar di dare risposte a persone che mettono avanti bisogni così immediati e fondamentali. Ci vuole una grande forza d’animo anche per stare da questa parte del bancone. Quella più tranquilla, perché, in sostanza, io un lavoro ce l’ho!
Come cerco di rendermi utile?
Lavorando senza dimenticare mai quella bambina che scriveva le ore sul foglio del quaderno, quel “padrone” avaro e disonesto, quel libretto della spesa con la copertina unta e bisunta…
Ah, un’ultima nota professionale: qualche link utile per chi sta cercando un lavoro.
Offerte Centri per l’impiego di Rimini e Riccione; offerte settore alberghiero della Riviera Romagnola; elenco Agenzie per il lavoro a Rimini; annunci di lavoro del settimanale Il Fo Romagna; sito infojobs.it.
Altri link utili nel sito del Centro per l’impiego.
Sperémma bén!