Trama e ordito, mamme che tessono la vita
 Copertina rossa, con un disegno originale di Dario Fo: si presenta così il libro di Maria Cristina Muccioli ("Trama e ordito - mamme che tessono la vita" - edizioni Il Ponte), giornalista pubblicista di Viserba. La presentazione ufficiale del volume, patrocinata dal Comune di Rimini, si è tenuta sabato 18 dicembre
1999 alle 17, alla Sala del Giudizio del Museo della Città . Hanno partecipato diverse personalità , fra cui il sindaco Alberto Ravaioli ed i responsabili della sede riminese dello I.O.R. (Istituto
Oncologico Romagnolo) alla quale è destinata parte del ricavato delle vendite.
Copertina rossa, con un disegno originale di Dario Fo: si presenta così il libro di Maria Cristina Muccioli ("Trama e ordito - mamme che tessono la vita" - edizioni Il Ponte), giornalista pubblicista di Viserba. La presentazione ufficiale del volume, patrocinata dal Comune di Rimini, si è tenuta sabato 18 dicembre
1999 alle 17, alla Sala del Giudizio del Museo della Città . Hanno partecipato diverse personalità , fra cui il sindaco Alberto Ravaioli ed i responsabili della sede riminese dello I.O.R. (Istituto
Oncologico Romagnolo) alla quale è destinata parte del ricavato delle vendite.
Partendo da una piccola storia della tela fatta in casa, in parte già pubblicata a puntate sul settimanale diocesano "Il Ponte", la Muccioli ha cercato testimonianze dalla viva voce degli anziani, ma anche proverbi, modi di dire, indovinelli che fanno riferimento al "ciclo della canapa". Maceri, gramole e gramolette, fusi, connocchie, filarini, dipanatoi, licci, navette, telai... Un "revival", in linguaggio semplice ed immediato, dedicato a mamme e nonne romagnole.
La seconda parte del libro, con l'aiuto degli stampatori dell'antica Bottega Pascucci di Gambettola, approfondisce la tecnica e la tradizione delle stampe a ruggine, tipica espressione dell'artigianato romagnolo che da oltre due secoli abbellisce i tessuti casalinghi.
Infine, sul filo dei ricordi di mamme e nonne, una terza parte riservata a mamme di personaggi più o meno noti che hanno avuto a che fare con fusi e telai (fra gli altri, don Oreste Benzi ed il sindaco di Rimini Alberto Ravaioli).
Alla stesura di "Trama e ordito" hanno partecipato, con le loro testimonianze: Benedetto
Benedetti, don Oreste Benzi, Anna Cenni, Massimiliano Filippini, Riccardo Pascucci, Renato Piccioni, don Piergiorgio Terenzi, Atalia Tresoldi.
Intervista all' autrice
dicembre 1999

La figlia dell'autrice, Cinzia, con fuso e rocca per filare, in una delle fotografie ricostruite al Museo Etnografico di Santarcangelo (foto di Alvaro Angelini).
Come nasce questo libro?
L'idea è partita nel 1998, quando un capo-redattore del Ponte, sapendo della mia passione per le tradizioni contadine e per il dialetto, mi ha suggerito un'inchiesta su alcuni oggetti ormai scomparsi. Pensando a mia madre, m'è venuta l'idea di approfondire un aspetto del suo passato che mi ha sempre incuriosita: le tele fatte a mano. Quindi ho cercato notizie su fusi, rocche, dipanatoi, gramole e gramolette, pettini, telai, torselli...
E' un libro difficile? Solo per "addetti ai lavori"?
No, assolutamente! Uso un linguaggio semplice ed immediato, parole di tutti i giorni. Ci sono molte citazioni in dialetto, proverbi, modi di dire, indovinelli. Tutto, però, seguito dalla traduzione in italiano. Lo vedo adatto anche per le scuole, per ricerche sul passato e sulle tradizioni contadine.
Perchè il sottotitolo "mamme che tessono la vita"?
Strada facendo, dopo aver pubblicato le prime puntate della mia "favola della tela" sul Ponte, ho incontrato diversi lettori che mi raccontavano delle loro mamme che, come la mia, in passato avevano tessuto o lavorato la canapa. Donne umili ma forti, che hanno incrociato, con fatica, non solo i fili dei telai, ma anche quelli delle vite dei loro figli. Il libro raccoglie quindi i ricordi di altri figli, personaggi molto noti (come don Oreste Benzi ed il sindaco Ravaioli). Alla fine del percorso mi sono accorta di aver scritto un omaggio a tutte le donne semplici, alle donne vere. Alle nostre piccole-grandi mamme e nonne.
Alcuni brani di Trama e ordito
Dario Fo: come e perchè
I miei, agricoltori di Gambettola (e' Bosc) hanno abitato nei Fondi di Sala (comune di Cesenatico) dal dopoguerra fino al 1963. Prima in via Pavirana, poi in via Vetreto, dove io sono nata.
Era la notte del 23 giugno 1958.
Racconta la mamma che quel giorno, nonostante le prime doglie, lavorò nei campi: bisognava raccogliere i fagiolini. Lei si spostava col suo sgabello, per lavorare da seduta, mentre le mie sorelle e mio fratello (8, 9 e 12 anni) le portavano i cesti (i gavagn).
Fino all'età di tre anni ho parlato solo il dialetto. Poi, quando la famiglia ha fatto il passo qualificante ed è scesa "a marina" (prima a Cesenatico poi Gatteo a Mare), uno zio già "cittadino" rimproverò i miei genitori.
"Non sta bene che una bimba piccola parli in dialetto!"
E così da quel giorno in casa si parlarono due lingue, non senza difficoltà . Sarà per questo che da grande ho voluto impararne altre?
I miei sono riusciti a farmi studiare. Conosco l'inglese, il tedesco, il francese. Ogni tanto provo a scrivere e parlare in dialetto, con tanti errori d'ortografia e pronuncia.
Il babbo, ormai ultra-ottantenne, brontola e protesta: "Sa tot i sacrifizi c'o fat a fèla studiè, cla burdèla! Adess l'artorna indrì a scor e' dialet!" (Con tutti i sacrifici che ho fatto per farla studiare, quella bambina! Adesso ritorna a parlare il dialetto!).
L'idea di rivolgermi a Dario Fo per il libro mi era venuta non per una questione di "storia", perchè non lo immaginavo figlio di contadini. Poteva essere invece la "geografia" ad avvicinarci.
Cercherò di chiarire.
Da diversi anni Dario Fo e Franca Rame hanno scelto per la loro seconda casa la campagna di Sala di Cesenatico. Precisamente via Vetreto.
Sì, la stessa! L'anello che unisce Dario e Cristina è una questione di pochi metri: la casa della mia tela e quella del premio Nobel della letteratura sono vicine.
Pensando a questa bella coincidenza, armata di coraggio e faccia tosta, ho tentato il contatto.
Riccione, settembre 1999: presentazione dell'ultimo libro di Fo. L'occasione giusta per un'intervista, incaricata dal quotidiano riminese con cui collaboro.
Intervista riuscita e pubblicata.
Successo anche per la proposta di collaborazione: il premio Nobel si è dimostrato interessato all'idea.
Però, accidenti, quanti impegni! In giro per il mondo, sempre indaffarato con spettacoli, progetti, interviste, premiazioni. Non riesce proprio a trovare tempo per me. Comincio a pensare che dovrò rinunciare...
Ecco invece entrare in gioco il destino.
Appena due giorni dopo quell'intervista, al matrimonio di un'amica comune, ritrovo Raffaella, che non vedevo da dieci anni. Da ragazzine stavamo sempre assieme. Poi le strade si sono allontanate, per motivi di lavoro e... matrimonio.
Le racconto la mia carriera di "giornalista per caso", il libro, i sogni, i progetti.
E lei: "Sei proprio uguale a Riccardo, un mio conoscente. Anche lui sognatore, romantico, sempre positivo. Come te. Trova sempre il bello in qualsiasi cosa. Dovete conoscervi!"
Prima coincidenza: Riccardo è un Pascucci, della famosa stamperia di Gambettola che ha alle spalle quasi duecento anni di storia.
Avevo già pensato ad un capitolo sulla stampa a ruggine: una sorta di cornice alla mia tela.
In più: proprio i Pascucci, oltre vent'anni fa, hanno colorato le mie tovaglie. Quelle che la mamma ha ricavato dai torselli rimasti a lungo nascosti nei bauli, dando così libero sfogo al suo semplice genio artistico: preziosi ricami a giorno ed intarsi ad uncinetto per rifinire il tutto.
Riccardo fa il primo passo. Informato da Raffaella sul mio lavoro in corso, mi telefona dopo qualche giorno.
"Se ti interessa, ho diverse fotografie d'epoca che riguardano il ciclo della canapa. Ideali per il tuo libro. Perchè non vieni a vederle?"
Proposta accettata al volo, naturalmente.
Qualche giorno dopo, mentre affascinata ammiravo il lavoro degli stampatori della bottega dei Pascucci, Riccardo, accompagnandomi nella visita, mi dice:
"Adesso ti faccio vedere una cosa che ti piacerà di sicuro".
Ecco, un quadro incorniciato appeso alla parete. La base è carta-paglia gialla, con disegni di fiori sparsi qua e là , ammucchiati, scompigliati. Non allineati come sulle tele in vendita... E, su questa base originale, salta all'occhio un disegno inconfondibile, che riconosco immediatamente, perchè simile ad un altro che ricordo sul libro "La vera storia di Ravenna".
"E' di Dario Fo!"
"Proprio così. Come hai fatto a riconoscerlo subito?"
Dario Fo va spesso a trovare Riccardo per procurarsi la carta su cui rimangono stampate le "prove". Le usa come base per schizzi e disegni, con un risultato molto originale.
Da tempo cercavo una copertina per il mio libro ed avevo pensato di utilizzare uno degli stampi più antichi dei Pascucci.
Speravo anche in un contributo del "premio Nobel", romagnolo d'adozione: mi sarei accontentata di due righe di presentazione.
E, invece, ho trovato il massimo: la copertina giusta, già fatta, disegnata da questo artista poliedrico.
Una sorta di "gioco del destino" che continua: come in un appassionante puzzle anche questa tessera ha trovato, nel momento giusto, il suo posto.
Quel disegno appeso in casa di Riccardo, ad un paio di chilometri dal luogo dove le mie tele ed io siamo nate, sembrava quasi aspettare me.
Dario, interpellato, ha approvato l'idea: a lui il "grazie" più grande per la nostra
"Danza fra i girasoli" (carta, colori e fiori di Riccardo Pascucci, disegni di Dario Fo, parole di Maria Cristina Muccioli).
LE STAMPE A RUGGINE
Testimonianza di Riccardo Pascucci
Riccardo Pascucci, insieme al fratello Giuseppe ed al cugino Francesco, è l'erede di questa tipica arte romagnola. Un mestiere che ama e che racconta volentieri.
"Tintori e stampatori da oltre cinque generazioni: questa è la famiglia in cui sono nato. Il metodo di lavoro non è cambiato: ora come allora stampiamo i tessuti naturali usando stampi di legno di pero incisi a mano ed il color ruggine ricavato da un'antica ricetta segreta.
Oggi la tela è prodotta industrialmente, ma nel passato si stampava quella tessuta in casa, specialmente con la canapa. Intrecci di fili che mi hanno sempre affascinato. Ho molti ricordi dell'infanzia legati alle tele casalinghe: atmosfere irripetibili, dove il babbo raccoglieva noi bambini e, seduto sullo scalino di casa, raccontava il suo lavoro. Meglio delle favole.
Ricordo quella volta che, mentre parlava, teneva in mano il filo dell'aquilone: il grosso gomitolo di canapa si srotolava e lui ricordava quando il cortile era animato dalle sartine. Sedute sotto l'albero di noci, quasi tutte vestite di scuro, univano a punto spighetta alcuni teli per ricavarne lenzuola. Accanto al pozzo, di solito, stavano le più giovani, sempre allegre e chiacchierine: erano le ricamatrici. Rifinivano con il 'giornino' gli asciugamani per i corredi da sposa.
Quand'ero piccolo entravo nella vecchia bottega come fosse un antro magico: odori, rumori, ombre, colori... Il grande mangano stirava i torselli e scricchiolava, schiacciando la stoffa col suo peso. I tessuti appena stampati, appesi sulle canne in alto, sulle teste, ondeggiavano lenti. Un ragazzo di bottega batteva il mazzetto sul bancone, per stampare una coperta da buoi con l'effigie di Sant'Antonio. E, nell'aria, quel forte odore d'aceto. Lo stesso che si sente oggi appena si varca la soglia della bottega. Lo stesso odore che ha accompagnato l'infanzia del babbo, del nonno, del bisnonno. I Pascucci che, dagli inizi dell'Ottocento, si sono tramandati di padre in figlio i segreti di quest'arte 'povera'.
Poter varcare la soglia del terzo Millennio con la consapevolezza d'essere depositario di qualcosa di 'antico' e prezioso mi emoziona."
Danza fra i girasoli
Era il 10 agosto 1999, una bella giornata di sole. A mezzogiorno si affaccia sulla soglia della bottega un signore con un grande cappello bianco in testa.
"Buon giorno!"
Lo riconosco subito: è Dario Fo. Frequenta la stamperia da diverso tempo ed ormai siamo in confidenza. Viene a Gambettola, dalla vicina casa di Sala di Cesenatico, per procurarsi qualcosa che gli è utile per un hobby che lo diverte molto: quello della pittura.
Da noi raccoglie i fogli di carta-paglia che usiamo per ricoprire il banco di lavoro e sui quali appoggiamo la tela per non macchiarla: rimangono stampati in maniera irregolare dal colore che passa fra la trama della stoffa, che funge da filtro. La sovrapposizione casuale dei decori rende questa carta unica ed originale: la base ideale per quelli che diventano i capolavori di Dario.
Mentre gli passavo un fascio di fogli che gli avevo tenuto da parte, uno cadde per terra. Mentre lo raccoglievo, feci notare a Dario che era impresso con disegni di girasoli, uno dei motivi a cui sono più affezionato.
"Quando troverà il tempo per fare un disegno per me? Magari su questa carta piena di girasoli?"
"Se mi dà un pennarello, glielo faccio subito."
Non me lo sono fatto ripetere! Il mio cuore batteva forte, mentre lo osservavo tracciare, appoggiato sul bancone, le prime linee del suo disegno. Lo osservavo in silenzio, quasi incredulo. Il suo volto era fiero e sorridente.
Ad un certo punto mi chiese del colore rosso, che presi fra quelli che usiamo per le stoffe.
"E' bello..." diceva compiaciuto tamponando con un pennello quel colore.
Quando pensò di aver terminato, mise la firma, in basso (Dario Fo 99). Poi, che strano, prese il disegno e lo lasciò cadere in terra, sul vecchio pavimento di mattoni della bottega.
"In quella posizione si vede meglio!"
Sottovoce, ammirato, m'è venuto spontaneo un commento:
"E' una danza: lei ha disegnato una danza fra i girasoli."
"Ecco, è proprio il titolo giusto. Mi passi subito il pennarello, ce lo scrivo sopra."
E' nata così la nostra "Danza fra i girasoli".
Un'opera d'arte che mi è molto cara. 'Mia' nel senso pieno della parola.
Dal seme al telaio
Alcune fasi della lavorazione della fibra di canapa
(brani estratti da "Trama e ordito")
LA BATTITURA
Quando la canapa, finalmente, era ben secca, si considerava pronta per essere battuta. L'operazione della battitura (cioè staccare la fibra dalla "bacchetta") avveniva nell'aia, in allegre veglie operose al chiar di luna.
Un grosso tronco terminante in alto a forcella veniva usato come "furzloun, par scavzè la canva"(forcellone, per scapezzare la canapa). La donna faceva scorrere in avanti le mannelle che il marito, armato di bastone, batteva e ribatteva, frantumando gli steli. Ne uscivano i "canarèl" (canapuli).
Bela burdèla fresca campagnola
"Batibatt e strecca un occ..." è il ritornello della canzone "A gramadora",
di Aldo Spallicci e Cesare Martuzzi, meglio conosciuta come "Bèla burdèla". Ripercorre la storia della tela casalinga. Evoca le serate in cui gramole e gramolette richiamavano ragazze e filarini sulla stessa aia...
da i cavell e da j occ coma e' carbon,
da la bocca piò rossa d'na zarsola
te t'si la mi passion.
Batibatt e strecca un occ,
strecca un occ e batibatt.
A'l fasegna ste baratt?
T'a m'dè un s-ciaf ch'a t'dagh un bes.
Grama, grama murèta un po' sgarbèda
ch'l'è bel a fè l'amor in aligrì,
sora al manè dla canva spintaccèda
me at' stagh sempar da drì.
Ligul filè int la rocca dla nunena,
gavettul d'azza bianchi int' e' bulì,
e' linzùl fresch ad tela casalena,
muretta a ch' bel durmì!
Bella ragazza fresca campagnola/dai capelli e dagli occhi come il carbone,/dalla bocca più rossa d'una cerisuola (bacca di biancospino)/tu sei la mia passione./Battibatti e strizza un occhio/strizza un occhio e battibatti/ lo facciamo questo baratto?/ Mi dai uno schiaffo che ti do un bacio./Gramola, gramola, morettina un po' sgarbata,/ ch'è bello far l'amore in allegria/sopra i mannelli della canapa scapigliata,/io ti sto sempre daccanto./Lucignoli (trecce di canapa) filati nella rocca della nonnina,/matasse d'accia bianche nel bollire/e lenzuoli freschi di tela casalinga,/moretta che bel dormire!
Gramole e gramolette
Dopo taglio, macerazione e battitura iniziava l'operazione della gramolatura (gramadora) che spesso veniva eseguita nelle aie di notte, nonostante il divieto della Chiesa.
Le mannelle di tiglio venivano passate, una ad una, alla gramola piccola e poi a quella grande.
"E' gramlèt", preparato con assicelle rudimentali, aveva una sola lama di percussione invece delle due-tre della "gramla", chiamata a ripulire dalle ultime schegge legnose il fascio di canapa.
Il lavoro era accompagnato da canti e balli e qualche... ubriacatura, come racconrta Benedetto Benedetti nel capitolo successivo.
PETTINATURA
"E' cuncen" ed i suoi pettini
Dopo l'ultima maciullatura le mannelle (qualcuno le chiamava già matasse) venivano scrollate ad una ad una con le mani, annodate o piegate in due "parchè li n's sgumbiess" (affinchè non si aggrovigliassero) ed infine riposte in un sacco o appese a fasci alle travi di un ripostiglio.
La pettinatura poteva essere fatta direttamente dal contadino; più spesso i raccolti abbondanti mobilitavano il canapino (e' cuncen) che, in cambio di una piccola paga (spesso in natura) girava di casa in casa coi suoi attrezzi.
Dbì canavè!
Era l'invito rivolto al canapino offrendogli da bere e significa sia "bevete canapino" sia "bevete, chè ne abbiamo!"
Su di un tavolaccio si legavano con corde robuste due pettini di grandezza diversa: "e' sgrafi" (il più grande, detto anche "grafiòn, scavcion") e la "pitnena" (il pettinino).
Entrambi erano costituiti da una base rettangolare di legno e da acuminati denti d'acciaio sporgenti su linee parallele.
Le donne lavoravano in coppia. La prima accostava al pettine grande una mannella di tiglio e con un abile strappo la tagliava in due o tre pezzi di 70-80 centimetri ciascuno. Poi passava un pezzo "in't e' sgrafi", prima in un senso poi nell'altro, per far uscire le schegge e la polvere.
Ripetendo questi movimenti la "cuncèna" (o il "cuncèn") lasciava tra i denti del pettine "e' capèc" (il capecchio), una prima fibra grossolana, sporca e da scartare.
Il capecchio finiva spesso per accendere il fuoco o, graffiante com'era, per raschiare gli scarponi invernali. Quello migliore poteva essere usato come imbottitura per gli angoli dei materassi di crine o, in qualche raro caso, per tessere ruvidi strofinacci o pessimi sacchi, che facevano vergognare al mulino!
Il secondo scarto che rimaneva fra i ferri del pettine era la stoppa, che veniva messa dentro un cesto per essere poi collocata, "mana a mana" (manciate appallottolate) in un sacco, da dove sarebbe stata prelevata per la filatura.
Intanto la "sfieza" (la chioma tigliosa rimasta indenne al graffio del pettine grande, passava nelle mani della seconda lavorante e tra i denti più fitti della "pitnena", lasciando ancora stoppa (di migliore qualità ) e, finalmente, i "leghli o legval" (legoro).
A volte questo si faceva ripassare nel medesimo pettine per ripulirlo ulteriormente: si otteneva così "e' garzol" (il garzuolo).
"Al sfiezi" di legoro e garzuolo venivano legate alle estremità e raggruppate in mazzi. Venivano così conservati per la filatura, o ceduti in parte al padrone, o venduti alla "canavena", che poi li smerciava alle fiere e ai mercati, da novembre a marzo, insieme a vari tipi di corda.
LA FILATURA
Quando Berta e Bice non volevano filar...
Fila, Berta, chè e' tu marit e vò la cverta!
Se te t'a n'filarè, e' marit ta n'l'avrè.
Fila, Berta, che il tuo marito vorrà la coperta!
Se non filerai, il marito non l'avrai!
Ah, questa Berta, che non voleva filare!
Ma ce n'è anche per Bice, un'altra bella vagabonda: per lei, non era mai il momento buono per mettersi a lavorare.
Fila, Bice, se vuoi le camicie!
Non posso filar, mi fa freddo alle dite;
se può venire l'estate,
quante fusa ne voglio filar!
Fila, Bice, se vuoi le camicie!
Non posso filar, mi fa caldo alle dite;
se può venire l'inverno,
quante fusa ne voglio filar!
Le brave donne, invece, cominciavano a filare in autunno, quando le veglie erano più lunghe ed i lavori dei campi diminuiti.
Il tempo dedicato alla filatura era fino a Natale: l'anno nuovo doveva essere riservato al lavoro del telaio.
A ricordare queste scadenze, molti proverbi tramandati di mamma in figlia.
Chi prema 'd Nadel u n'fila,
dop Nadel e suspira.
Chi prima di Natale non fila,
dopo Natale sospira.
Chi d'Nadel l'an fila,
d'carnevèl suspira.
Chi di Natale non fila,
per carnevale sospira.
Natale senza filo, Pasqua senza tela.
E anche per la quantità del lavoro da farsi per ogni sera c'era un proverbio apposito:
La breva filandèra, la fa tri fus par sera.
La brava filatrice fa tre fusi per sera.
Tre fusi: non pochi. Bisognava lavorare di buona lena! Sedute accanto all'arola o nelle stalle al caldino prodotto dalle bestie, le donne si fissavano la rocca al fianco sinistro (di solito stretta al grembiale) e con le dita allungavano il filo che usciva dalla pergamena (e' curnec).
Via via che il filo si allungava, si lavorava di... sputo. Sì, proprio così: la fibra, ruvida, andava bagnata continuamente. Di solito si usava la saliva (parchè l'an lighes) e coi denti si ripulivano le sporgenze nodose (i stupaciun). Per procurarsi saliva abbondante, si usava tenere in bocca una castagna secca (un cuciarol) oppure chicchi secchi di fava, lupini, bucce d'arancia essiccate.
Caghè e' stupèn.
Cagare lo stoppino (venire al dunque).
Dondolina della filatrice
Questa dondolina è rimasta nelle mie orecchie. In braccio alla nonna o al babbo, andavo su e giù, mentre mi tenevano per le mani e mi cantilenavano:
Bel burdèl
fat a canèl,
magna luvèin
chiga stupèin.
Bel bambino, fatto come un cannello,
mangia lupini, caga stupaccini.
Racconta la mia mamma:
"La mi suocera l'am dèva d'al mileini znini znini, da tnei in t'la paranenza".
(La mia suocera mi dava delle piccole mele, da tenere nel grembiule).
Femmine, buone solo a filare
La rocca povera era di canna. In alto veniva intagliata per creare un rigonfiamento, entro il quale la filatrice metteva "i cuciarol" utili alla salivazione. Le rocche di legno, di solito destinate alle signore, avevano invece il rigonfiamento fatto con stecchetti di canna applicati ed erano abbellite da disegni a fuoco.
La rocca era coperta dalla pergamena, che veniva acquistata. Poteva anche essere regalata dai frati "cercantoni", quando passavano nelle case a chiedere la carità .
Le pergamene più lussuose erano ben sagomate, colorate e disegnate, in cartapecora o, addirittura, in lamina d'argento.
Le donne più povere si costruivano la propria pergamena anche con vecchie cartoline o altro cartone riciclato.
Sua maestà , la rocca
Esistono numerosi proverbi e modi di dire che fanno riferimento alla rocca ed al fuso. Ambedue simboli di femminilità e del ruolo sociale della donna, erano spesso richiamati dai misogini con intento dispregiativo.
E, invece, la rocca in mano della reggitrice della casa ("l'arzdora") altro non era che lo scettro di una regina. Insieme a "s-ciadur" (matterello) e "paranènza" (grembiale), simbolo della supremazia femminile nelle grandi famiglie contadine di una volta.
Dret com un fus.
Diritto come un fuso.
Mestr' Indùs
da una rovra u n' cavèt un fus.
Maestro Indugio
da un rovere non cavò un fuso.
Avè-n un fus e una gavètla.
Averne un fuso e una matassa.
(essere stanchissimo e morto di sonno)
Il detto alludeva in maniera figurata alla donna che aveva vegliato riuscendo a filare un fuso e una matassa di accia.
L'è mej aquistè 'na roca
che perd un capèl
Meglio acquistare una rocca che perdere un cappello.
(Si diceva per consolare il padre quando nasceva una femmina, evento non sempre desiderato).
La dona quand la n'ha gnint da fè,
l'ha da ciapè la roca e l'ha da filè;
s'la fila anc sol da e' nes a la boca
la n'ha da stè d'an s'metar la roca.
La donna quando non ha niente da fare deve prendere la rocca e filare;
se fila soltanto dal naso alla bocca non deve stare da smettere la rocca.
A forza 'd dei, ad dei,
us cheva di fus nech d'int e' trev.
A forza di darci, di darci, si cavano fusi anche dal trave.
Frulla-frulla.
Con la mano destra la filatrice faceva roteare il fuso, sul quale la gugliata, man mano che si allungava, veniva avvolta.
Per ottenere una matassa (gavètla) servivano cinque o sei fusi. La matassa, tenuta unita da un filo annodato (la pandegla) veniva poi imbiancata con una lunga procedura casalinga, in cui veniva usata la cenere del focolare.
LA TESSITURA
Nelle veglie serali, da settembre a gennaio, si lavorava quindi di rocca e fuso; i mesi di febbraio e marzo erano invece riservati alla tessitura.
Una volta predisposto l'ordito, il telaio occupava una sola donna in ogni casa. Le altre potevano dedicarsi a lavori di maglia, uncinetto e ricamo.
I tler
Il telaio rudimentale veniva creato dal "marangoun" (il falegname) che si preoccupava soprattutto di far bene le casse, la parte più delicata: incaricate di fare la "battuta", erano in faggio o quercia.
Il telaio si sistemava in una stanza apposita, la "cambra di tler" (sempre al plurale: i telai). Ben fermo, a pianterreno: se posto su di un pavimento ballerino in un piano rialzato della casa non avrebbe dato garanzie di sicurezza e di buon lavoro. Doveva essere ben orientato alla luce, possibilmente con una fiancata allineata alla grondaia.
Il telaio era munito di organi agili per ordito e trama, che lavoravano sotto la spinta delle mani e dei colpetti di due o più pedali (al piencli) collegati ai licci (i lèz, i lèc) i quali, alzando ed abbassando i fili dell'ordito, creavano via-via le bocche per i passaggi delle spole (al drugli, al navèti).
I cannelli della spola, che portavano il filo, erano realizzati con segmenti di canna grossi un dito e lunghi 5-6 centimetri. Si caricavano con uno strumento (e' rodli) azionato facilmente anche dai bambini. I piccoli di casa venivano reclutati per questo lavoro. Le tessitrici più organizzate affidavano spesso il lavoro dei cannelli ai bimbi del vicinato, ricompensandoli poi con piccole mance.
Preparazione dell'ordito
La preparazione dell'ordito era complicata e richiedeva il lavoro di più persone. Si fissavano al muro, verticalmente, stanghe di legno con pioli sporgenti su cui venivano tesi 20 fili (che potevano essere 15 o 10 per i tessuti più radi). Questi fili venivano fatti uscire uniti attraverso una spatola bucherellata (la spadarola).
I lunghi mazzetti di fili (al pajoli) si trasportavano, a trecce, dalle stanghe al telaio, attraverso l'intervento coordinato di tre o quattro persone. Si avvolgevano quindi al subbio posteriore, che era di forma cilindrica (e' sobi dla subieta) con i capi terminali tesi in lunghezza verso i licci e il battente fornito di pettine (al cassi de' petni).
Quindi venivano collegati con l'altro subbio (e' sobi dla tela), che raccoglieva il tessuto finito.
Tela urdida,
Dio l'aida
Tela ordita, Dio l'aiuta.
Parè e no èssar
l'è coma urdì e no tèssar.
Parere e non essere
è come ordire e non tessere.
Di venere e di marte...
Una volta che il telaio era pronto, la tessitrice iniziava il suo lavoro (mai di martedì o venerdì!).
Ma neppure in determinati periodi dell'anno, scanditi sempre da credenze che stanno fra sacro e profano.
La tela no cminzè
quand al campan i ha lighè.
Non cominciare la tela quando hanno legato le campane.
(La tradizione di non dare inizio a nuovi lavori quando sta per finire un ciclo dell'anno è antichissima. In questo caso colla morte del Signore finisce un periodo e ne ha inizio un altro).
Dopo aver controllato che i licci fossero ben collegati ai pedali e che il subbio della distribuzione fosse ben in "tireta" e avesse filo da dare, la donna cominciava con il lavoro delle mani (muovendo veloce la drugla in andata e ritorn) e dei piedi (abbassando ed alzando i pedali collegati ai licci).
Musica ritmata da colpi ben assestati della cassa con pettine incorporato.
Pettini del telaio: più alto è il numero, più fitti i denti, più fine la tela. Il numero indica in genere i denti presenti in un centimetro di lunghezza. Con i pettini 16 e 18, i più grossolani, si facevano sacchi, teloni, coperte. Per le lenzuola in genere occorreva il 30 o addirittura il 32. La numerazione continuava anche fino al 38, che era finissimo.
U s'è tirat int e' petan d'vinciot"
Si è tirato nel pettine da ventotto.
(Si diceva quando un ragazzo si vestiva a festa - "u s'era mudè").
Come quando, durante la tessitura, ad ogni tirata di tela "u s'dasèva l'imbosna, una còla d'rimuleta" (si dava l'imbosna, una colla di crusca) affinchè i fili dell'aza non si attaccassero l'un con l'altro. Era composta di crusca, farina gialla, farina bianca, cera, grasso ed acqua. Si faceva bollire, mescolandola come una polenta. Poi la si stendeva fra licci e subbio, per farla entrare fra i fili e renderli più scorrevoli. Così passavano fra i denti del pettine senza attorcigliarsi (ingambarles).
"Mazapegul" dal berrettino rosso
A proposito di "sgambetti" alla tessitrice, ecco la storiella di Mazapegul, dispettoso folletto romagnolo, com'è raccontata da Vittorio Tonelli.
"Sul batti e ribatti del pettine e dei pedali una giovane tessitrice ritmava canzoni d'amore in faccia alla tela nascente del suo corredo da sposa. Muoveva svelta la spola nella trama di quel tessuto di sogno. Ed ogni volta se la sentiva sfuggire di mano, a volte tra il brusìo dei cannelli agitati.
Ma chi era l'invisibile cavalier servente che le raccoglieva via via la drugla da terra, senza parole, nel respiro ovattato di un palpito?
Era... un folletto innamorato: lo stesso nanetto dal berretto rosso che di notte le giaceva sul ventre, platonicamente o che faceva i dispetti in casa, mettendo sottosopra le stanze, spegnendo le candele, spettinandola mentre dormiva."
E' mazapegul
ch'l a e' biritoci ròs
e la bèrba ad legul.
Il mazapegul, che ha il berrettuccio rosso e la barba di legolo.
(Dai ricordi di Marco Magalotti, di Sorrivoli).
Lo spiritello cambiava nome a seconda dei luoghi: mazapegul, caicarèl, zapà ider, fulèt, mazapes...
Fantasia popolare senza confini: il mazapegul romagnolo è presente anche in Puglia (mazzamuriello, munaciedde), a Roma(mazzamurello), ad Ancona e Jesi (mazzamurèllo), in Lucchesia (linchetto), in Campania (munaciello), in Lucania (monachiccio), sul Gargano (scazzanuridd).
Mamma Pierina, ai suoi tempi maga della tela, fa la ramanzina alla sua "burdèla" quarantenne
In cerca di conferma chiedo alla mamma se ricorda qualcosa a proposito del "mazapegul". Lei, come sempre pratica e realista, non smentisce lo stampo d'educazione che ha passato ai quattro figli e mi dice di non credere a tante storie fantastiche.
Lei ed il babbo nella loro lunga vita onesta e laboriosa ci hanno insegnato a confidare nelle nostre capacità , a tirarci su le maniche e ad essere... bravi "burdèl". Senza bisogno di prediche: bastava l'esempio.
"Se, e' fulèt! La tela l'as ingarbuglieva m'al doni pastruciouni! E' bsogna es preceisi e lavurè ben: e' fulèt l'era una scusa..."
(Sì, il folletto! La tela si aggrovigliava alle donne pasticcione. Bisogna essere precise e lavorare bene: il folletto era una scusa...).
Credenze e superstizioni della tessitrice
Non si dovevano mai lasciare in tensione i fili dell'ordito a telaio fermo, per non rischiare che il diavolo vi andasse nottetempo a ballare sopra, con intuibili conseguenze.
In caso di rotture del filo, conveniva menzionare il diavolo e dargli del dispettoso, perchè altrimenti sarebbe stato peggio.
Non si permetteva mai a nessuno, fosse anche un vicino di casa, di entrare nella stanza dei telai durante la lavorazione, perchè questa sarebbe stata più lenta e difficoltosa, con fili impazziti nei pettini e rotture che avrebbero fatto moltiplicare i nodi sulla tela.
Una donna incinta non doveva mai scavalcare le paiole nel momento del loro trasferimento nel telaio, perchè al nascituro si sarebbe attorcigliato il cordone ombelicale intorno al collo. Lo stesso effetto avrebbe avuto scavalcare corde di qualsiasi tipo, il torsello della tela steso sul prato, o mettersi a collana, mentre cuciva, una matassina di filato.
Tela larga. Tela lunga
In circa otto giorni di lavoro nasceva una tela lunga 30-40 metri e larga 65-70 centimetri.
La saggezza dei proverbi ha qualcosa da dire anche su queste misure.
La tela la s'fa longa com u s'vò
e lerga com u s' po'.
La tela si fa lunga come si vuole e larga come si può.
Perchè per l'ordito si usava il cotone, che era da comprare e non sempre disponibile; mentre la trama era realizzata con la canapa di produzione casalinga e quindi più abbordabile.
Ma c'era anche la "tela flandenta": chi non aveva soldi per comprare il cotone per l'ordito, faceva lavorare il telaio solo con l'accia, in tutti due i sensi del tessuto, usando le paiole a dieci fili.
Si ricavava così una tela di sola canapa: rada e meno forte, grossolana. Andava comunque bene per lenzuola, asciugamani, canovacci, teli di vario uso, coperte per bovini oppure sacchi di seconda qualità per la farina.
I tursèll
La tela, srotolata dal subbio anteriore, veniva accuratamente piegata.
In seguito, con ripetuti bucati nella cenere e con l'esposizione alla rugiada (la guazza) e al sole sarebbe stata imbiancata.
I rotoli così finiti (i tursèl) venivano riposti accuratamente.
Un pizzicotto viene spontaneo, quando le cosce del bimbo hanno quei bei rotolini di ciccia- E la nonna, soddisfatta, dice:
"Ac bèl tursèl!"
Che bel torsello!
Per la confezione, si poteva anche aspettare altri inverni ed altre veglie. Il nostro tesoro fatto in casa, intanto, veniva custodito in bauli e cassapanche, in attesa di essere trasformato da abili mani.
Ricami, pizzi, stampe a ruggine...
Lenzuoli, federe, tovaglie, asciugamani, strofinacci, tende, pezzuole per donne e bambini. Ma anche coperte per il bestiame e sacchi per la farina; mutandoni, camicie e sottovesti; abiti da lavoro, pantaloni.
Tutto in casa, tutto creato da queste meravigliose donne: le nostre mamme e nonne.
Corredi "a mezze dozzine"
Ora diamo un po' di numeri.
Con tre teli di almeno 65 centimetri d'altezza si potevano cucire lenzuoli da letto matrimoniali, mentre con 4 da 70 centimetri venivano fuori dei copriletto).
Com'era il corredo minimo per una ragazza contadina?
Ecco l'indispensabile:
4 magliette di lana;
6 camicie di canapa o cotone (da giorno e da notte);
6 paia di mutande di cotone;
6-12 pannolini di lino (o ricavati da lenzuoli vecchi);
6 lenzuoli da letto grandi di canapa, con 3 paia di federe possibilmente di cotone;
1 coperta di lana e 1 (preferibilmente stampata) di cotone per l'estate;
4 asciugamani da camera (in canapa e rifiniti);
4 asciugamani da cucina (canovacci) in tela scadente, rigata "a ruggine";
2 pannucce di tessuto simile;
4 strofinacci della peggiore accia;
2 tovaglie (raramente in lino), con tovaglioli (una dozzina) o senza.
Le ragazze più ricche, naturalmente, moltiplicavano per 2, per 3 (o anche di più) e abbondavano in lino e cotone, a scapito della più povera canapa.
Pizzi e ricami, per loro, erano rifiniture indispensabili, che impreziosivano ancora di più il contenuto di cassapanche e bauli.
La bonfinita
La conclusione del lavoro ai telai in molti posti veniva festeggiata in famiglia con la "bonfinita", che liberava la tessitrice e la riportava a sfaccendare nei campi.
Nell'occasione, per tradizione, si mangiava un gustoso bustrengh (un migliaccio di farina, pangrattato, formaggio secco, latte e uova) cucinato in una grande teglia di rame incoperchiata e ricoperta di brace.
Davvero si doveva festeggiare, dopo un così lungo lavoro!
Ripenso alla mamma, prendendo in mano i due licci che mi ha regalato ("A tessere m'ha insegnato la zia Maria, mamma di Anna. Per 'mettere su' questi due licci impiegammo una settimana").
Le mie figlie adolescenti, esperte navigatrici in Internet, mi chiedono se si tratti di oggetti provenienti da Marte e non riescono a capirne l'uso.
Io, invece, vado indietro di sessant'anni: vedo due piccole donne nella grande casa colonica "d' e' Bosc" (Gambettola). Zia e nipote chiacchierano fra loro ed intrecciavano con maestria forti fili di cotone su questi lunghi bastoni.
E poi, una seduta accanto all'altra sulla panchetta del telaio (l'esperta all'opera e la ragazzina ad osservarne i movimenti), iniziano il lavoro.
Per regalare a me, che sarei nata vent'anni dopo, la bella tovaglia che oggi le amiche mi invidiano.
Torna Su
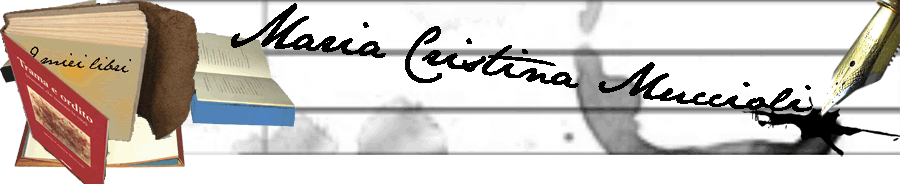

![email: mcmuccioli [at] yahoo.it](http://www.cristella.it/mail.gif) - Tutti i diritti riservati.
- Tutti i diritti riservati.